
Max Horkheimer (1895 – 1973)
Echi brechtiani nella visione di Horkheimer della civiltà, un presente senza riscatto e senza remissione, basato sull’accumulazione della sofferenza e dello sfruttamento.
Vista in sezione, la struttura sociale del presente dovrebbe configurarsi all’incirca così: Su, in alto, i grandi magnati dei trust dei diversi gruppi di potere capitalistici che però sono in lotta tra di loro; sotto di essi i magnati minori, i grandi proprietari terrieri e tutto lo staff dei collaboratori importanti; sotto di essi, suddivise in singoli strati, le masse dei liberi professionisti e degli impiegati di rango inferiore, della manovalanza politica, dei militari e dei professori, degli ingegneri e dei capoufficio fino alle dattilografe; ancora più giù i residui delle piccole esistenze autonome, gli artigiani, i bottegai, i contadini e tutti gli altri, poi il proletariato, dagli strati operai qualificati meglio retribuiti, passando attraverso i manovali fino ad arrivare ai disoccupati cronici, ai poveri, ai vecchi, ai malati.
Solo sotto tutto questo comincia quello che è il vero e proprio fondamento della miseria, sul quale si innalza questa costruzione, giacché finora abbiamo parlato soltanto dei paesi capitalistici sviluppati, e tutta la loro vita è sorretta da un’orribile apparato di sfruttamento che funziona nei territori semi-coloniali e coloniali, ossia in quella che è di gran lunga la parte più grande del mondo.
Larghi territori del Balcani sono una camera di tortura, in India, in Cina, in Africa, la miseria di massa supera ogni immaginazione. Sotto gli ambiti in cui crepano a milioni i coolie della terra, andrebbe poi rappresentata l’indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli animali, l’inferno animale nella società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali […]. Questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato.
Max Horkheimer, Crepuscolo. Appunti presi in Germania (1926-31), trad. it. Einaudi, Torino, 1977.
Carlo Emilio Gadda, Una mattinata ai macelli
“ … qualche animale appoggia la fronte a una barra (bavando una sua schiuma dalla bocca, a fiocchi) quasi per raggelare al contatto del ferro, dopo la scombussolata notte, il tumulto doloroso del proprio sangue. Qualche altro ha un corno mezzo divelto, e ne sanguina: il caglio scarlatto gli si è raggrumato giù per il muso, l’occhio immalinconito sembra dimandarne la cagione alle cose, al mondo” [Le meraviglie d’Italia, Einaudi, 1964].



 In questa seconda parte dell’Estratto del Trattato sula natura umana [1739] Hume espone la sua celebre dottrina della causalità secondo la quale
In questa seconda parte dell’Estratto del Trattato sula natura umana [1739] Hume espone la sua celebre dottrina della causalità secondo la quale 




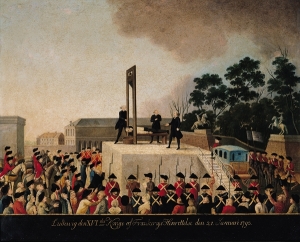
 Specismo e antispecismo nella chiara esposizione di uno dei principali filosofi animalisti italiani. Tratto da
Specismo e antispecismo nella chiara esposizione di uno dei principali filosofi animalisti italiani. Tratto da  Nel secondo dopoguerra il dibattito sui limiti della scienza
e della tecnologia era strettamente legato ai timori di distruzione
del genere umano legati alla bomba atomica. Oggi le nuove sfide sono quelle del postumano, in cui la ‘soglia’ dell’umano viene travalicata aprendo certamente grandi possibilità ma ponendo anche nuovi, complessi interrogativi. Ed è sul terreno del diritto
che si pongono le sfide più importanti: i princìpi di eguaglianza
e dignità devono essere il faro per rimanere umani. Uno degli ultimi contributi di Stefano Rodotà, pubblicato da MicroMega.
Nel secondo dopoguerra il dibattito sui limiti della scienza
e della tecnologia era strettamente legato ai timori di distruzione
del genere umano legati alla bomba atomica. Oggi le nuove sfide sono quelle del postumano, in cui la ‘soglia’ dell’umano viene travalicata aprendo certamente grandi possibilità ma ponendo anche nuovi, complessi interrogativi. Ed è sul terreno del diritto
che si pongono le sfide più importanti: i princìpi di eguaglianza
e dignità devono essere il faro per rimanere umani. Uno degli ultimi contributi di Stefano Rodotà, pubblicato da MicroMega.
Commenti recenti