Il pensiero di Kant rappresenta il punto più alto raggiunto dall’Illuminismo e dalla modernità e, al tempo stesso, l’inizio della sua dissoluzione, contenendo già gli elementi per il superamento (idealistico) della sua filosofia: il criticismo.
Indice
1. Introduzione: il dibattito sulla conoscenza ai tempi di Kant
2. Gli scritti precritici 1755-1763
2.1 La visione quantitativa e meccanicistica del cosmo
2.2 La critica del dogmatismo razionalista
2.3 Le letture di Kant
3. Verso la svolta critica: gli scritti tra il 1766 e il 1770
3.1 Il nuovo compito della metafisica
3.2 Il risveglio dal sonno dogmatico
3.3 L’annuncio delle forme a priori della soggettività
4. Il «tribunale della ragione» e la «rivoluzione copernicana»
4.1 Il problema della metafisica come scienza e la naturale tendenza ad essa della ragione
4.2 Il rovesciamento della prospettiva conoscitiva
4.3 La struttura della Critica della ragion pura
5. La fondazione della conoscenza oggettiva: i giudizi sintetici a priori
5.1 La teoria dei giudizi
5.2 L’uso dei giudizi analitico e sintetico nel dibattito filosofico
5.3 Il giudizio scientifico come sintetico a priori
6. L’estetica trascendentale
6.1 La funzione della sensibilità (o intuizione)
6.2 Le forme a priori della sensibilità: spazio e tempo
7. L’Analitica trascendentale
7.1 L’Analitica dei concetti
7.1.1 Intuizioni e concetti
7.1.2 L’Analitica trascendentale
7.1.3 Dall’intuizione al concetto: giudizi percettivi e giudizi d’esperienza
7.1.4 Le categorie o concetti puri dell’intelletto
7.1.5 La sintesi a priori dell’intelletto
7.1.6 La deduzione metafisica
7.1.7 La deduzione trascendentale e l’Io penso
8. L’analitica dei principi: lo schematismo trascendentale e l’uso delle categorie
9. Fenomeno e noumeno
10. La dialettica della ragione
10.1 La ragione pura come sede della parvenza trascendentale
10.2 La critica della cosmologia razionale e dell’idea del mondo come totalità
10.3 La critica della psicologia razionale e dell’idea dell’anima come sostanza eterna e incorruttibile
10.4 La critica della teologia razionale e delle prove dell’esistenza di Dio
11. L’etica
11.1 L’autonomia dell’etica dalla religione
11.2 La natura umana
11.3 Il compito della filosofia morale
11.4 Un’etica formale
11.5 Le massime della volontà
11.6 Il dovere e l’imperativo morale
11.7 L’imperativo categorico e le sue formulazioni
12. La Critica del giudizio
13. Gli scritti politici. La Risposta alla domanda: Cos’è l’Illuminismo?
Integrazioni, chiarimenti, sintesi: Immanuel Kant visto da vicino (Loescher); [dopo la videolezione 1] Maurizio Ferraris, Kant e l’Illuminismo; [dopo la videolezione 4] Gianfranco Marini, La mossa di Kant; filosofojoe, La differenza tra trascendente e trascendentale; [dopo la videolezione 6] filosofojoe, Spazio e tempo; [dopo la videolezione 9] filosofojoe, La Critica della ragion pura in tre minuti; Perché ci Sono Cose che Puoi Conoscere e Altre No]
Io ho avuto la felicità di conoscere un filosofo, che fu mio maestro.
Nei suoi anni giovanili, egli aveva la gaia vivacità di un giovane, e questa, credo, non lo abbandonò neppure nella tarda vecchiaia.
La sua fronte aperta, costruita per il pensiero, era la sede di una imperturbabile serenità e gioia; il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra; aveva sempre pronto lo scherzo, l’arguzia e l’umorismo, e la sua lezione erudita aveva l’andamento più divertente.
Con lo stesso spirito col quale esaminava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume, e seguiva le leggi naturali scoperte da Newton, da Keplero e dai fisici, accoglieva anche gli scritti allora apparsi di Rousseau, il suo Emilio e la sua Eloisa, come ogni altra scoperta naturale che venisse a conoscere: valorizzava tutto e tutto riconduceva a una conoscenza della natura e al valore morale degli uomini priva di pregiudizi.
La storia degli uomini, dei popoli e della natura, la dottrina della natura, la matematica e l’esperienza, erano le sorgenti che avvivavano la sua lezione e la sua conversazione. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente; nessuna cabala, nessuna setta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo, aveva per lui il minimo pregio di fronte all’incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé; il dispotismo era estraneo al suo spirito.
Quest’uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Immanuel Kant: la sua immagine mi sta sempre dinanzi.
Johann Gottfried Herder
Immanuel Kant era nato a Könisberg (Prussia), oggi Kaliningrad (Russia), in una famiglia di modeste condizioni economiche. Suo padre, infatti, era maniscalco. Compì i suoi studi nella città natale, dove fu avviato alla matematica, alla fisica e istruito alla filosofia razionalista di Leibniz e Wolff.
Il suo pensiero rappresenta il punto più alto raggiunto dall’Illuminismo e, al tempo stesso, l’inizio della sua dissoluzione, visto che contiene già gli elementi per il superamento (idealistico) della sua filosofia.
Dal punto di vista gnoseologico, la sua filosofia è un punto di svolta della modernità, ma ancora più influenti sono le pagine di etica della Critica della Ragion pratica nelle quali fonda il comportamento morale sull’imperativo categorico e su un cielo stellato ormai svuotato di divinità prescrittive e quelle della Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo? nella quale identifica l’Illuminismo, appunto, come “l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità da imputare a se stesso”:
«L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da un difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo ».
La sua filosofia prende, però, avvio da altri temi: quelli del dibattito scientifico dell’epoca (sull’origine dell’Universo, sulle comete e sui terremoti, dopo il disastro di Lisbona del 1755) e di quello gnoseologico, ai quali offre soluzioni mature e rivoluzionarie.
1. Introduzione: il dibattito sulla conoscenza ai tempi di Kant
Il diciottesimo secolo ha rappresentato per la riflessione filosofica sulla conoscenza, l’inizio di due modi opposti di concepirla: quello razionalista, secondo cui ciò che sappiamo ha origine in una capacità di comprensione della realtà per noi innata, e quello empirista, per il quale la conoscenza della realtà si basa sulla capacità della sensibilità umana di essere impressionata dagli stimoli esterni e della nostra mente di elaborarli.
Entrambi questi modi di concepire la conoscenza umana, ai tempi di Kant erano arrivati a maturità: con Hume, paradossalmente, gli empiristi avevano finito per togliere validità proprio alla conoscenza empirica mentre, con Wolff, i razionalisti erano giunti a legittimare come reale tutto ciò che non è contraddittorio.
Hume, infatti, aveva distinto tra la conoscenza che otteniamo a priori, senza far ricorso all’esperienza, dalla conoscenza a posteriori derivante appunto dall’esperienza, osservando che tutto ciò che conosciamo per osservazione potrebbe sempre essere diverso da come lo vediamo perché nessuna esperienza può mai esaurire tutta la realtà: l’esperienza non è, quindi fonte, di conoscenza vera (dimostrata).
Wolff, invece, dal versante razionalista, aveva avvicinato ragione e realtà, pensiero ed essere, fino a far coincidere verità di fatto (verità contingenti, come quelle empiriche, il cui opposto è possibile) e verità di ragione (verità necessarie basate sul principio di identità e non contraddizione, il cui contrario è impossibile), finendo per dichiarare reale tutto ciò che è pensabile senza contraddizione.
Kant, educato alla filosofia razionalista ma fortemente influenzato dalla scienza newtoniana, finirà per assumere un atteggiamento antimetafisico, prefiggendosi di correggere gli errori millenari del modo metafisico di argomentare, al fine di costruire i presupposti di ogni nuova metafisica che voglia proporsi come scienza.
2. Gli scritti precritici (1755 – 1763)
2.1 La visione quantitativa e meccanicistica del cosmo

Il terremoto di Lisbona del 1755
I primi scritti kantiani vertono su questioni di fisica, cosmologia e geologia e testimoniano come l’avvio della riflessione kantiana sia caratterizzata dalla graduale assimilazione della prospettiva scientifica newtoniana e dunque dall’accettazione di un modello di spiegazione quantitativo e meccanicistico del cosmo.
Spicca tra questi primi scritti, la Storia naturale della natura e teoria del cielo, del 1755, che vede Kant applicare le leggi della fisica newtoniana alla spiegazione dell’origine dell’universo e formulare l’ipotesi – alla quale perverrà autonomamente in seguito lo scienziato francese Laplace – che al suo inizio ci sia una nebulosa primitiva (e non Dio).
L’anno seguente pubblica tre scritti sui terremoti – argomento divenuto di bruciante attualità dopo il sisma che aveva distrutto Lisbona (1755) – legando il fenomeno alle forze magmatiche presenti nelle cavità terrestri ed escludendo ogni ricorso a fantomatiche punizioni divine negli eventi straordinari o catastrofici.
mappa
2.2 La critica del dogmatismo razionalista
Kant affronta i problemi della scienza del suo tempo da filosofo tendendo quindi, a offrirne un inquadramento metafisico e a porre in primo piano il problema del metodo della conoscenza.
Nel trattare questi temi comincia già il suo distanziamento dalla metafisica wolffiana (alla quale era stato formato al Collegium Fridericianum e all’Università Albertina) perché era convinto, in opposizione a Wolff, che il solo fatto che un concetto sia pensabile – perché non contraddittorio e dunque formalmente possibile – non significhi ancora che sia reale.
In altre parole, Kant escludeva che tra piano logico e piano reale (cioè tra pensare ed essere) vi fosse coincidenza immediata. Ad esempio, posso rappresentarmi un animale mitologico come l’ippogrifo e attribuirgli predicati non contraddittori, ma al concetto che ne ricavo non tocca l’esistenza, che per Kant può essere solo constatata sul piano dell’esperienza (ma non dimostrata a priori).
escludeva che tra piano logico e piano reale (cioè tra pensare ed essere) vi fosse coincidenza immediata. Ad esempio, posso rappresentarmi un animale mitologico come l’ippogrifo e attribuirgli predicati non contraddittori, ma al concetto che ne ricavo non tocca l’esistenza, che per Kant può essere solo constatata sul piano dell’esperienza (ma non dimostrata a priori).

L’esigenza di distinguere tra piano logico e piano reale, tra pensiero ed essere è al centro di un altro importante scritto del 1763, L’unico argomento possibile per una dimostrazione dell’esistenza di Dio, che verteva sulle diverse argomentazioni per dimostrare l’esistenza di Dio.
Kant esamina la nozione di esistenza dimostrando la sua irriducibilità all’ordine logico dei concetti (l’esistenza non è una qualità, dirà, ma la capacità di una cosa di essere oggetto d’esperienza di qualcuno).
Il filosofo distrugge qui il classico argomento ontologico di Anselmo da Aosta che aveva dimostrato l’esistenza di Dio partendo dal concetto di un essere perfettissimo che, in quanto tale, non può mancare di nulla, dunque nemmeno dell’esistenza.
Kant confuta quest’argomentazione, sostenendo che l’esistenza non può in nessun caso far parte del concetto perché il concetto di una cosa non cambia, sia che la cosa esista o che non esista. Il concetto di pinguino sarebbe insomma perfetto di per sé anche se i pinguini non esistessero.
 Kant propone l’esempio dei cento talleri, osservando che i 100 talleri che si hanno in tasca sono diversi da quelli che stiamo solo pensando solo perché quelli che ho in tasca posso spenderli, ma non si tratta di una differenza di essenza, come credeva Anselmo: i 100 talleri esistenti non sono più perfetti e di valore dei 100 talleri pensati. Sarebbe infatti come dire che i cento talleri pensati sono 90 e quelli reali pienamente 100. 100 talleri, insomma, sono 100 talleri, che siano in tasca o nella nostra mente.
Kant propone l’esempio dei cento talleri, osservando che i 100 talleri che si hanno in tasca sono diversi da quelli che stiamo solo pensando solo perché quelli che ho in tasca posso spenderli, ma non si tratta di una differenza di essenza, come credeva Anselmo: i 100 talleri esistenti non sono più perfetti e di valore dei 100 talleri pensati. Sarebbe infatti come dire che i cento talleri pensati sono 90 e quelli reali pienamente 100. 100 talleri, insomma, sono 100 talleri, che siano in tasca o nella nostra mente.
Kant mostra che le cose pensate e quelle reali hanno la stessa essenza, ciò che cambia è solo la loro esistenza che è qualcosa che si aggiunge dall’esterno.
L’esistenza è infatti la posizione di una cosa, cioè la sua possibilità di essere oggetto di esperienza di qualcuno (essere posta per qualcuno), per cui può essere constatata solo partendo dall’esperienza, non per via dimostrativa.
E’ impossibile allora dimostrare l’esistenza di Dio partendo dal suo concetto come fa Anselmo: c’è un solo argomento per farlo ed è il principio di ragion sufficiente, secondo cui non c’è nulla che avvenga senza causa e l’unica cosa che si spieghi da sola, che sia (spinozianamente) causa sui, è Dio.
Successivamente Kant rifiuterà anche questa argomentazione – che coincide con la prova a posteriori dell’esistenza di Dio – della quale non era pienamente convinto nemmeno nel 1763, visto che concludeva L’unico argomento possibile osservando che
se è necessario convincersi dell’esistenza di Dio, non è altrettanto necessario che la si dimostri.
E’ con questo scritto che Kant si inoltra nel cuore stesso dei problemi della metafisica, cioè quell’ambito del sapere che si occupava dei problemi relativi all’anima come sostanza, al mondo come totalità e a Dio, paragonata a «un abisso senza fondo» e a «un oceano tenebroso senza sponde e senza fari».
mappa

2.3 Le letture di Kant

Jean-Jacques Rousseau
Gli anni che precedono la svolta critica del 1770 sono anche quelli delle letture di Rousseau, Hume e dei moralisti inglesi del ‘700 (Shaftesbury, Hutcheson). Il filosofo svizzero lo influenza soprattutto sul piano dell’etica e gli insegnerà un modo nuovo di guardare alla dignità dell’uomo:
Io sono per tendenza un ricercatore. Sono assetato di tutte le conoscenze […]. Ci fu un tempo in cui credevo che ciò potesse costituire l’onore dell’umanità e disprezzavo il popolo ignorante. E’ Rousseau che mi ha aperto gli occhi. Questa illusoria vanità sparì, imparo a onorare gli uomini e mi sentirei assai più inutile del più comune dei lavoratori, se non credessi che questa considerazione può dare a tutte le altre questo valore: ristabilire i diritti dell’umanità.
I. Kant, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 1764
3. Verso la svolta critica: gli scritti dal 1764 al 1770
3.1 Il nuovo compito della metafisica
Aristotele dice in un qualche luogo: « Vegliando, noi abbiamo un mondo comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo ». A me sembra che si possa invertire l’ultima proposizione, e dire: quando di diversi uomini ciascuno ha il suo proprio mondo, è da presumere che essi sognino.
Persuasi di ciò, di fronte agli architetti dei diversi mondi ideali campati in aria, dei quali ciascuno tranquillo occupa il suo mondo con esclusione degli altri, standosene l’uno nell’ordine delle cose che Wolff ha costruito con poco materiale di esperienza, ma più concetti surrettizi, e l’altro in quello che Crusius ha prodotto dal nulla con la magica forza di alcune parole, pensabile ed impensabile, noi, dinanzi alla contraddizione delle loro visioni, pazienteremo, finché questi signori sian usciti dal sogno.
Poiché, quando una buona volta essi, a Dio piacendo, veglieranno completamente, cioè apriranno gli occhi ad uno sguardo che non esclude l’accordo con un altro intelletto umano, nessuno di essi vedrà nulla che, alla luce delle loro prove, non appaia anche a tutti gli altri evidente e certo, ed i filosofi abiteranno nello stesso tempo un mondo in comune, qual è quello che già da gran tempo hanno occupato i matematici; e questo importante avvenimento non può differirsi più a lungo, se è da credere a certi segni e presagi che son già comparsi da qualche tempo sull’orizzonte delle scienze [I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica (1766)].
Nei quattro anni che vanno dai Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica (1766) – scritto in cui Kant ironizza sulle fantasticherie a cui può approdare la mente umana, dall’occultismo alla metafisica, quando abbandona il terreno sicuro dell’esperienza – alla Dissertazione del 1770 La forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile, nella riflessione di Kant si fa progressivamente strada l’idea che il compito della metafisica non sia di rispondere a quesiti che oltrepassino le possibilità conoscitive dell’uomo, ma di diventare una «scienza dei limiti della ragione».
3.2 Il «risveglio dal sonno dogmatico»

David Hume (1711 – 1776)
Il riconoscimento dei limiti della conoscenza non spinge comunque Kant verso un generico empirismo o una posizione scettica.
Il filosofo sottolinea in più circostanze di essere stato influenzato dal pensiero di Hume e dalle sue obiezioni alla metafisica, ma ritiene che si possa rispondere al suo scetticismo se si trovano delle condizioni di conoscenza che non derivano dall’esperienza sensibile, ma che anzi la rendono possibile, organizzando il materiale empirico e dandogli la forma di un sapere compiuto.
Così si esprime nella Prefazione ai Prolegomeni ad ogni futura metafisica:
Hume partì principalmente da un unico ma importante concetto della metafisica, cioè quello della connessione di causa ed effetto […] ed invitò la ragione, che in metafisica asserisce di aver generato quel concetto dal suo seno, a rendergli conto con qual diritto essa pensa che qualche cosa possa essere così costituita che, se essa è posta, perciò anche qualche altra cosa debba necessariamente esser posta; giacché ciò dice il concetto di causa […]. La questione non era se il concetto di causa sia legittimo, adoperabile e indispensabile riguardo ad ogni conoscenza della natura, perché Hume non lo aveva mai posto in dubbio, ma se esso sia pensato a priori dalla ragione, e in tal modo abbia una verità intrinseca indipendente da ogni esperienza; a questo Hume aspettava una risposta. […] Lo confesso francamente: l‘avvertimento di David Hume fu proprio quello che, molti anni or sono, mi risvegliò dal sonno dogmatico e dette un tutt’altro indirizzo alle mie ricerche nel campo della filosofia speculativa.
3.3 L’annuncio delle forme a priori della soggettività
Il preannuncio di quella svolta si ha proprio nella Dissertazione del 1770, nella quale per la prima volta Kant teorizza che le condizioni per la conoscenza dei fenomeni sono da ricercare nelle forme a priori della soggettività.
In questo scritto Kant stabilisce, in opposizione a Wolff, che tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale non c’è una differenza di grado, ma di genere: la conoscenza sensibile non ha per oggetto una conoscenza ancora oscura e confusa (mentre quella intellettuale una conoscenza chiara), ma «le cose come appaiono», i fenomeni, mentre la intellettuale ha per conoscenza «le cose come sono», i noumeni.
La maturazione del criticismo avverrà solo quando Kant si chiarirà, dopo una riflessione decennale, che i concetti dell’intelletto non si rivolgono alla realtà in sé, ma agli stessi dati della sensibilità, svolgendo una funzione di ordinamento dell’esperienza.
4. Il «tribunale della ragione» e la «rivoluzione copernicana»
4.1 Il problema della metafisica come scienza e la naturale tendenza ad essa della ragione
Dalla pubblicazione della Dissertazione alla prima edizione della Critica della ragion pura (1781) passa un decennio di intensa riflessione in cui Kant giunge ad una nuova soluzione al problema della metafisica.
Da un lato, egli esclude la possibilità di una metafisica che sia scienza delle cose che sono al di fuori dei confini dell’esperienza, dall’altro, ridetermina il significato della metafisica come ricerca di quanto può essere conosciuto “a priori”, sia in campo scientifico che pratico (morale).
Il punto di partenza è dunque il problema della metafisica che non è ancora arrivata alla maturità di una scienza e si presenta, anzi come «un campo di battaglia» «di controversie senza fine».
La ragione umana, per Kant, non può semplicemente prescindere dai problemi in campo metafisico, perché le è connaturata la tendenza ad ascendere sempre più nella ricerca dei principi che spiegano la realtà, allontanandosi sempre più dall’esperienza.
La ragione, infatti, ha di peculiare
di essere gravata di questioni che essa non può evitare, poiché le sono assegnate dalla sua stessa natura di ragione, ma a cui non può nemmeno dare risposta, poiché tali questioni oltrepassano ogni potere della ragione umana. Kant, Prefazione alla Critica della ragion pura, trad. it, I, Milano, 1976, p. 7.
Ogni tentativo della ragione di oltrepassare l’esperienza ha finito per precipitarla in una serie di oscurità e contraddizioni, di qui la tendenza allo scetticismo ma, avverte Kant, è inutile fingere indifferenza nei confronti di queste indagini, perché
«il loro oggetto non può risultare indifferente alla natura umana».
Resta però da verificare se la metafisica possa giungere allo statuto di una scienza.
Per farlo occorre che la ragione si rivolga a se stessa e
istituisca un tribunale che la garantisca nelle sue giuste pretese.
Questo tribunale che prende il nome di critica della ragion pura, in cui la ragione decide circa la possibilità o l’impossibilità della metafisica e, in generale, della conoscenza pura a priori, nonché alle sue fonti e alla sua estensione.
Il termine critica (dal greco krino, separare, decidere in giudizio) è assunto da Kant come rifiuto di ogni accettazione dogmatica e insiem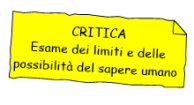 e come esame dei limiti e delle possibilità del sapere umano.
e come esame dei limiti e delle possibilità del sapere umano.
Kant si muove, da questo punto di vista nel clima intellettuale aperto dal Saggio sull’intelletto umano di Locke – vedi l’Epistola al lettore -, nel quale il filosofo inglese si era appunto chiesto «cosa possiamo sapere?».
4.2 Il rovesciamento della prospettiva conoscitiva
Ogni interesse della mia ragione (tanto quello speculativo quanto quello pratico) si concentra nelle tre domande seguenti:
Che cosa posso sapere? (rispondere a questa domanda è il compito della Critica della ragion pura)
Che cosa devo fare? (rispondere a questa domanda sarà il compito della Critica della ragion pratica)
Che cosa ho diritto di sperare? (Kant risponde a questa domanda con la Critica della ragion pratica e gli scritti sulla religione)
[Kant, Critica della ragion pura – Dottrina trascendentale del metodo]
Finché si considera l’oggetto come qualcosa di “dato” esteriormente alla conoscenza che il soggetto ne ha, si resta necessariamente impigliati o nella concezione razionalista o in quella empirista.
Si tratta allora di operare un rovesciamento di tale prospettiva assumendo l’ipotesi che gli oggetti debbano regolarsi sulla nostra conoscenza.
Ciò vuol dire che non esiste prima un oggetto di cui poi facciamo esperienza, ma che il modo in cui si costituiscono i fatti dell’esperienza è determinato dalle funzioni trascendentali della ragione: è grazie ad esse che l’esperienza è possibile.
Secondo Kant, la filosofia ha bisogno di una rivoluzione nel modo di pensare simile a quella delle scienze che si sono incamminate su una «via sicura» quando hanno compreso che non sono le cose a legittimare il carattere oggettivo delle conoscenze, ma il riconoscimento dell’intervento attivo del soggetto conoscente in rapporto all’oggetto.
Occorre pertanto una trasformazione del modo di pensare analoga a quella di Copernico, quando davanti alle difficoltà dell’astronomia tolemaica e del sistema geocentrico dell’universo, pensò di invertire il rapporto tra la terra e il sole e
«di far ruotare lo spettatore e far star ferme le stelle» [Kant, Critica della ragion pura, I].

Soggetto e oggetto dell’indagine kantiana è la ragione pura, cioè le facoltà conoscitive a priori. La ragione deve infatti indagare su se stessa per poter stabilire i limiti e l’estensione della propria facoltà di conoscere in modo obiettivo.
Questa ricerca comporta l’adozione di un nuovo punto di vista filosofico, definito da Kant trascendentale:
Chiamo trascendentale – dice Kant – ogni conoscenza che si occupi non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti in quanto questa deve essere possibile a priori.
Con il punto di vista trascendentale, Kant porta la ricerca su condizioni del conoscere che siano a priori, prima di ogni esperienza empirica. Si tratta di un riorientamento complessivo di tutta la tematica gnoseologica che Kant definisce una rivoluzione copernicana.
In questa nuova prospettiva, certi caratteri degli oggetti e i legami che si stabiliscono tra loro sono spiegati in base al nostro modo di conoscere.
Essi sono perciò considerati come fenomeni (cose che appaiono), non come cose in sé (noumeni).
In questo modo, tutto il problema della conoscenza è ricondotto al nostro modo di conoscere che, essendo uguale per tutti, è garante di conoscenza oggettiva, seppure limitata alla realtà fenomenica.
La rivoluzione kantiana si basa perciò su questi punti essenziali: la limitazione della conoscenza al mondo dei fenomeni e la conseguente negazione che la nostra conoscenza possa attingere una realtà sovrasensibile; la ricerca delle condizioni pure del conoscere.
4.3 La struttura della Critica della ragion pura

5. La fondazione della conoscenza oggettiva
5.1 La teoria dei giudizi
Nell’introduzione alla Critica della ragion pura, Kant affronta il problema dell’oggettività della conoscenza (della concordanza delle nostre rappresentazioni con le cose) nei termini di una indagine sul giudizio.
Il giudizio è l’attribuzione di un predicato a un soggetto con pretesa di verità.
Dunque il problema di come noi conosciamo le cose coincide, dal punto di vista logico, con il problema del criterio con il quale si connettono soggetto e predicato. Tale connessione può essere di due tipi: analitica e sintetica.
Il giudizio analitico è quello in cui ciò che il predicato esprime è già compreso nel concetto del suo soggetto, come nell’esempio “tutti i corpi sono estesi”, essendo l’estensione implicita nel concetto di corpo. Il giudizio, in questo caso, non fa altro che sviluppare analiticamente il contenuto concettuale del soggetto (perciò Kant lo chiama anche esplicativo).
Il giudizio analitico è a priori “perché in esso la connessione tra soggetto e predicato è pensata per identità”: un corpo viene pensato necessariamente come esteso. Il giudizio analitico è dunque universale e necessario (il suo contrario non può cioè essere pensato senza contraddizione).
Nel giudizio sintetico, invece, la connessione tra soggetto e predicato viene pensata “senza identità”: il predicato contiene qualcosa che non è compreso nel concetto del soggetto, come nell’esempio “tutti i corpi sono pesanti”.
La pesantezza non è infatti un elemento che si trova nel concetto generale di corpo perché è possibile pensare un corpo anche senza peso.
Il predicato, nel giudizio sintetico, è collegato al soggetto in forza dell’esperienza, dunque i giudizi sintetici sono a posteriori e, in quanto tali, non hanno né universalità né necessità.
Il problema che Kant esamina è quindi quello di giudizi, come quelli analitici che, in quanto a priori, dimostrano il loro contenuto in modo necessario e universale ma, in quanto semplici svolgimenti di ciò che è contenuto nel soggetto sono sterili, cioè non aggiungono alla nostra conoscenza nulla di più di quanto si sappia mentre, al contrario, i giudizi sintetici, essendo a posteriori (cioè ricavati dall’esperienza) ci danno conoscenze soltanto possibili ma feconde, cioè aggiungono nuove informazioni e permettono di far avanzare la conoscenza.
5.2 L’uso dei giudizi analitico e sintetico nel dibattito filosofico

David Hume (1711 – 1776)

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Razionalismo ed empirismo hanno dato diversa rilevanza ai giudizi analitico e sintetico: il razionalismo ha dato priorità al giudizio analitico. Leibniz, ad esempio, afferma il carattere legislativo del pensiero, la sua capacità di produrre a priori le forme della realtà.
L’empirismo, invece, particolarmente Hume, mette in luce il carattere sintetico dell’esperienza.
Con la sua critica al concetto di causa Hume, infatti, prova che il nesso causa-effetto non è analitico (cioè pensabile a priori, quindi necessario e universale), ma sintetico: l’effetto non può venire dedotto necessariamente dalla causa, ma è associato ad essa dall’esperienza.
Dal razionalismo e da Leibniz, Kant accetta che la scienza deve avere carattere di universalità e necessità e che quindi essa non può essere fondata empiricamente, anche se il suo debito verso Hume è dichiarato.
Durante la sua ricerca, Kant trova conferma dunque dell’insufficienza dell’empirismo, ma è anche consapevole che il problema della conoscenza non può essere risolto nel quadro tradizionale del razionalismo: occorre, allora, dimostrare come sia possibile una conoscenza costituita a partire dai dati dell’esperienza, ma, al tempo stesso, a priori.
5.3 Il giudizio scientifico come sintetico a priori
Tornando alla teoria del giudizio, si può allora dire che né il giudizio analitico, né il giudizio sintetico soddisfano i criteri della conoscenza scientifica.
Il giudizio analitico, infatti, è universale e necessario, ma può chiarire solociò che è già conosciuto, non produrre nuove conoscenze; il giudizio sintetico invece, estende il sapere, ma è privo di necessità: la conoscenza invece deve essere sintetica, cioè comprensiva di elementi empirici, ma al tempo stesso fondata razionalmente.
La forma del giudizio scientifico deve essere perciò il giudizio sintetico a priori, in cui il predicato non è già compreso nel concetto del soggetto e tuttavia è collegato ad esso in modo universale e necessario.
L’esistenza dei giudizi sintetici a priori, è dimostrata dai concetti della matematica e della fisica.
I giudizi della matematica sono a priori, in quanto portano con sé quella necessità che non può essere ricavata dall’esperienza (5 e 7 saranno sempre tali indipendentemente dagli oggetti d’esperienza), e sono al contempo sintetici: nel giudizio 7+5=12, il risultato non è ottenuto analiticamente dalla somma dei concetti di 5 e di 7, nel 12 infatti è contenuto qualcosa che non era né nel 5 né nel 7.
Per la matematica e la fisica occorre, quindi, dimostrare non se siano possibili, ma come siano possibili i giudizi sintetici a priori.
La dimostrazione di come sia possibile l’attribuzione con necessità e universalità di un predicato a un soggetto che non lo contiene è svolta da Kant nelle prime due parti della Critica: L’Estetica e l’Analitica trascendentale. Diverso è il caso della metafisica: la questione in questo caso è se essa sia possibile.
6. L’Estetica trascendentale
 6.1 La funzione della sensibilità (o intuizione)
6.1 La funzione della sensibilità (o intuizione)
Nella prima e principale sezione della Critica, la Dottrina trascendentale degli elementi, Kant fa l’inventario di quelle forme e funzioni a priori che dovranno condurlo alla fondazione delle scienze fisiche e matematiche e a chiedersi se una metafisica come scienza sia possibile.
La prima parte di questa sezione si intitola Estetica trascendentale e contiene un’indagine sulla conoscenza sensibile.
Gli oggetti ci vengono dati attraverso la sensibilità che è la capacità del soggetto di essere modificato dagli oggetti dell’esperienza, cioè di avere sensazioni.
La rappresentazione immediata dell’oggetto è chiamata da Kant intuizione: la forma di conoscenza propria della sensibilità che coglie i fenomeni (non è infatti possibile l’intuizione degli oggetti intellettuali, cioè i noumeni, visto che di essi non possiamo fare esperienza).
Poiché parliamo di fenomeni, cioè degli oggetti come ci appaiono, occorre presupporre l’esistenza di ciò che Kant chiamerà successivamente noumeno, cioè la cosa in sé, qualcosa che è solo pensabile, ma non può essere oggetto di esperienza.
Gli oggetti della nostra esperienza, infatti, sono costituiti di una materia (che corrisponde alla sensazione) e una forma, attraverso cui sono ordinati e colti da noi (evidente l’aristotelismo di questa concezione).
Tale forma, per Kant, non appartiene ai fenomeni, ma al nostro modo di conoscerli, è cioè soggettiva (del soggetto, non dell’individuo) e ha un’origine a priori.
6.2 Le forme a priori della sensibilità: spazio e tempo


Isaac Newton (1643 – 1727)
Kant offre una nuova soluzione al problema dello spazio e del tempo, visti da Newton come entità assolute, concependole come le forme a priori dell’intuizione attraverso le quali si dà l’esperienza del mondo fenomenico.
Essi dunque, da un lato operano solo in presenza dei dati dell’intuizione empirica ma, dall’altro, non sono ricavati dall’esperienza, come vorrebbe l’empirismo, anzi ne costituiscono la condizione.
Lo spazio non è dunque una caratteristica inerente gli oggetti o la loro relazione, ma la forma a priori del senso esterno.
Analogamente, il tempo non è altro che la forma a priori del senso interno, cioè dell’intuizione di noi stessi e del nostro stato interno.
Per questo anche il tempo non è ricavato dalla successione dei fenomeni, ma al contrario è ciò che rende possibile comprendere la successione di fenomeni.
Dopo aver chiarito la natura di spazio e tempo come forme a priori della sensibilità, l’estetica trascendentale si conclude con la definizione degli oggetti dell’intuizione che Kant chiama fenomeni, ovvero le cose in quanto conosciute da noi, non come sono in se stesse.
Infatti,
«che cosa siano gli oggetti presi in se stessi, a prescindere dall’intera ricettività della nostra sensibilità, ci è del tutto ignoto».

7. La Logica trascendentale. L’Analitica trascendentale
7.1 L’Analitica dei concetti
7.1.1 Intuizioni e concetti
L’Estetica trascendentale ha portato a compimento l’indagine delle forme pure della sensibilità, spetta ora alla Logica trascendentale estendere tale esame alla conoscenza intellettuale.
Se nella sfera della sensibilità avevamo a che fare con intuizioni, ora siamo di fronte ai concetti dell’intelletto.
Intuizioni e concetti sono le due grandi fonti della conoscenza che si costituisce proprio nel loro rapporto:
«senza sensibilità – dice Kant – nessun oggetto ci verrebbe dato, senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche».
Solo dalla loro unione può venire la conoscenza.
7.1.2 L’Analitica trascendentale: il pensare
 La Logica trascendentale, come studio delle forme a priori dell’intelletto si divide in due parti: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale.
La Logica trascendentale, come studio delle forme a priori dell’intelletto si divide in due parti: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale.
L’Analitica trascendentale tratta dei fondamenti a priori della conoscenza scientifica ed esamina l’uso trascendentale delle categorie e l‘Io penso.
La Dialettica trascendentale è invece un’analisi della logica dell’apparenza che nasce dalla tendenza della ragione ad oltrepassare i limiti dell’esperienza.
Nella Dialettica sarà, da ultima, la metafisica a presentarsi di fronte al “Tribunale della ragion pura”.
Al termine dell’Estetica trascendentale, Kant ha mostrato come le forme a priori della sensibilità unifichino i dati dell’esperienza.
Ma, se non ci fossero altre strutture formali della coscienza, oltre a quelle ricettive della sensibilità, il mondo fenomenico ci apparirebbe solo come un insieme caotico di impressioni sensibili, non come un complesso articolato di oggetti e di eventi.
Alla ricettività dell’intuizione bisogna dunque aggiungere la spontaneità del pensiero, cioè l’operazione specifica dell’intelletto che consiste nell’unificare il molteplice dato. Tra sensibilità e intelletto c’è infatti un rapporto di correlazione funzionale.
7.1.3 Dall’intuizione al concetto: giudizi percettivi e giudizi d’esperienza
 Per chiarire la funzione specifica dell’intelletto rispetto alla sensibilità, Kant distingue tra giudizi percettivi e giudizi d’esperienza.
Per chiarire la funzione specifica dell’intelletto rispetto alla sensibilità, Kant distingue tra giudizi percettivi e giudizi d’esperienza.
I giudizi percettivi sono soltanto soggettivi e contingenti perché si limitano a descrivere il contenuto empirico delle nostre percezioni.
Nei Prolegomeni, Kant propone l’esempio:
«questo sasso, posto al sole, si è riscaldato»,
e sottolinea la diversità tra questo tipo di giudizio e il giudizio d’esperienza
«il sole riscalda gli oggetti»
che contiene una connessione necessaria che nel primo è assente.
Dal punto di vista del contenuto, i due giudizi sono identici (il messaggio è che il sole riscalda gli oggetti), ciò che li differenzia è il tipo di collegamento che nel giudizio percettivo consiste semplicemente nel mettere in relazione due percezioni (l’una relativa alla luce del sole, l’altra al calore della pietra) sulla base della sola successione temporale, mentre nel giudizio d’esperienza entra in gioco un concetto intellettuale puro: quello di causa, che stabilisce un nesso necessario tra le percezioni vincolante per ogni soggetto (universale).
È in questo concetto puro dell’intelletto che si trova dunque la validità oggettiva (cioè universale e necessaria) di un giudizio d’esperienza.
L’esperienza di cui parla Kant, non è una realtà già data davanti a noi che ci limiteremmo a rispecchiare passivamente, ma è una costruzione del nostro intelletto attraverso l’elaborazione della materia proveniente dalle sensazioni.
Il senso della “rivoluzione copernicana” è, infatti, che noi non abbiamo accesso agli oggetti come cose in sé, ma gli oggetti sono dati a noi come fenomeni solo attraverso le condizioni logiche a priori che rendono possibile l’esperienza.
L’oggettività della conoscenza va dunque intesa come l’universalità e necessità del nesso che si stabilisce tra i fenomeni, garantito non da un mondo di cose in sé, ma dall’intelletto e dai suoi concetti puri.
7.1.4 Le categorie o concetti puri dell’intelletto

Aristotele (384 – 322 a.C.)
Kant affronta tale problema nell’Analitica dei concetti nella quale mostra come l’intelletto operi su rappresentazioni di oggetti, le intuizioni, che nel giudizio vengono poste in connessione secondo determinate regole che corrispondono ad altrettante funzioni a priori dell’intelletto.
Kant ritiene quindi possibile risalire dall’esame dei diversi tipi di giudizio ai corrispondenti concetti puri dell’intelletto che egli chiama categorie.
Kant utilizza qui la logica tradizionale (aristotelica) usando anche il termine aristotelico di «categorie».
Tuttavia, mentre per Aristotele le categorie sono forme della predicazione che corrispondono a un preciso contenuto ontologico (sono cioè modi di organizzazione del pensiero fondati su caratteristiche specifiche della realtà), per Kant esse sono funzioni a priori dell’intelletto, il cui scopo è di unificare i dati dell’intuizione.
Il loro carattere soggettivo non ne fa però delle idee innate, nel senso di un patrimonio di idee precostituite di cui la nostra mente disporrebbe (cioè “cose” presenti nella nostra mente, ma capacità, cioè funzioni).
Per quanto non derivino dall’esperienza, il loro valore conoscitivo esiste infatti solo in relazione ad essa. Le categorie kantiane sono infatti funzioni attraverso cui l’intelletto unifica il materiale sensibile offerto dalle intuizioni.
7.1.5 La sintesi a priori dell’intelletto
 Kant individua le categorie nella deduzione metafisica, in cui dimostra che questi concetti puri hanno origine nella spontaneità dell’intelletto e si accordano completamente con le funzioni logiche generali del pensiero.
Kant individua le categorie nella deduzione metafisica, in cui dimostra che questi concetti puri hanno origine nella spontaneità dell’intelletto e si accordano completamente con le funzioni logiche generali del pensiero.
La deduzione del carattere a priori delle categorie pone due problemi filosofici:
- Chiarire come è possibile che funzioni a priori della soggettività diano luogo a una conoscenza oggettiva;
 Spiegare in che modo le categorie, che hanno una natura puramente formale, possano applicarsi alla materialità dell’esperienza.
Spiegare in che modo le categorie, che hanno una natura puramente formale, possano applicarsi alla materialità dell’esperienza.
Alla prima questione Kant risponde con la deduzione trascendentale dei concetti puri dell’intelletto, alla seconda, con la dottrina dello schematismo trascendentale (Analitica dei principi).
7.1.5 La deduzione metafisica
Per Kant, pensare significa giudicare, cioè connettere concetti che sono a loro volta sintesi di dati sensibili.
Il nostro intelletto, infatti, non ha la capacità di intuire direttamente gli oggetti, ma può conoscerli solo discorsivamente, cioè connettendo rappresentazioni differenti attraverso concetti e giudizi.
Per esempio, nel giudizio «tutti i corpi sono divisibili», il predicato «divisibilità» è connesso al concetto di «corpo», quest’ultimo, a sua volta può essere predicato di altri concetti, come nel giudizio «ogni cosa materiale ha un corpo».
Per isolare gli elementi a priori del pensiero (categorie), Kant considera quindi i tipi di giudizio che possiamo esprimere, ricollegandosi alla tradizione aristotelico-scolastica (alla quale apporta quale modifica).
E individua 4 gruppi di giudizi (quantità, qualità, relazione, modalità) ognuno dei quali articolato in 3 tipi (ad esempio, il giudizio di quantità può esprimere i concetti di singolarità, molteplicità e universalità, o totalità).
7.1.6 La deduzione trascendentale e l’Io penso
Kant utilizza il termine “deduzione” nel senso giuridico di dimostrazione.
Nello specifico, si tratta qui di dimostrare la legittimità delle categorie e del loro uso, cioè di provare il diritto dei concetti puri dell’intelletto, che sono dati a priori, di valere per gli oggetti empirici, che sono dati a posteriori.
La soluzione offerta da Kant, colloca nel centro della soggettività il principio oggettivo del conoscere.
Ribadito che le categorie devono essere intese come condizioni a priori della possibilità dell’esperienza, Kant osserva che il presentarsi della molteplicità dell’esperienza all’interno di una sintesi unitaria è possibile solo se il soggetto unifica spontaneamente questo molteplice.
L’operazione di unificazione e sintesi dell’intelletto è possibile perché il soggetto percepisce se stesso come autocoscienza o centro di esperienze: l’unificazione all’interno di sé precede, infatti, ogni altra unificazione degli oggetti d’esperienza.
 Questa autocoscienza originaria, identica per struttura in tutti i soggetti conoscenti, è chiamata da Kant «Io penso» o appercezione trascendentale.
Questa autocoscienza originaria, identica per struttura in tutti i soggetti conoscenti, è chiamata da Kant «Io penso» o appercezione trascendentale.
L’io penso è il principio di unificazione formale del pensiero che è la condizione di possibilità della conoscenza del mondo. È con l’io penso infatti che il soggetto riconosce le sue rappresentazioni come proprie.
È importante notare che l‘Io penso non è una realtà sostanziale, cioè una res, una cosa, com’era quella rivelata dal cogito cartesiano, né coincide con la coscienza empirica che è oggetto del senso interno, è invece semplicemente, un principio stabile di unificazione, senza il quale la conoscenza sarebbe impossibile.
In conclusione, per Kant, le categorie non sono altro che forme particolari di sintesi mediante cui opera l’Io penso (da cui traggono la loro validità oggettiva).
Ma le categorie valgono solo se si applicano ai dati delle intuizioni sensibili, cioè a dati da unificare. Il loro uso legittimo, quindi, è solo quello empirico, cioè nei confronti dell’esperienza perché, prese di per sé, le categorie sono «vuote», cioè non conoscono nulla. Perché ci sia conoscenza, come si è visto, è necessario infatti che operino insieme concetti ed intuizioni.
8. L’Analitica dei principi: lo schematismo trascendentale e l’uso delle categorie
Perché l’incontro tra intuizioni e concetti si verifichi concretamente, occorre un termine intermedio, che possieda al tempo stesso sia il carattere formale della categoria (intellettiva e universale) che il carattere materiale dell’intuizione (sensibile e individuale). Come possiamo, infatti, rappresentarci concretamente una categoria (per es. la causalità), che di per sé non può essere intuita mediante i sensi, rendendola congruente con due fenomeni empirico-sensibili (come la luce del sole e il riscaldarsi della pietra)? La risposta va cercata per Kant nello “schematismo dei concetti puri dell’intelletto”,
«un’arte nascosta nelle profondità dell’anima umana, il cui vero maneggio difficilmente noi strapperemo mai alla natura, per svelarlo davanti ai nostri occhi».
La rappresentazione mediatrice, che è omogenea da un lato con la categoria, dall’altro con l’intuizione, è lo schema trascendentale. Ma quale facoltà lo produce, visto che tale schema deve possedere aspetti sia dell’intuizione sia della categoria? Kant indica la facoltà dell ‘immaginazione pura (o produttiva), che presenta come il primo effetto che l’intelletto produce sulla sensibilità.

immagine di un triangolo

un poligono formato da tre angoli e tre lati
Per capire che cosa Kant intenda per “schema”, occorre anzitutto distinguerlo dalla semplice immagine. Esso infatti non si limita a riprodurre in modo semplificato i tratti di un singolo oggetto, ma costituisce la regola, o se si vuole il modello, per costruire l’immagine d’un oggetto qualsiasi. Un’immagine è, per esempio, quella di un determinato triangolo che trovo tracciata su un foglio, mentre lo schema del concetto di triangolo in generale è la regola che la mia immaginazione segue per tracciare la figura di qualsiasi triangolo e che, diversamente dalla figura data empiricamente, non può esistere che nel pensiero.
Lo schema è poi una sorta di adattamento preliminare dell’intuizione pura del tempo a una categoria dell’intelletto.
Per esempio, negli schemi delle categorie di relazione, alla categoria della sostanza corrisponde lo schema della permanenza del reale nel tempo; quello della causalità è la successione del molteplice, in quanto soggetta a una regola; quello dell’azione reciproca è la simultaneità. Ma permanenza, successione e simultaneità costituiscono determinazioni a priori del tempo, per cui l’intuizione temporale (che, come sappiamo, “filtra” anche le rappresentazioni esterne) viene formalizzata secondo regole che traducono, a livello della sensibilità, le funzioni categoriali dell’intelletto, rendendole in un certo modo intuitive. Le categorie trovano così applicazione alla forma del senso interno (il tempo) e, attraverso questa, all’intera esperienza.
Gli schemi mediano ulteriormente tra le categorie e l’esperienza perché stabiliscono i principi generali dell’intelletto puro che sono le regole generali dell’uso delle categorie. Come 4 sono i gruppi di categorie, 4 sono anche i principi dell’intelletto puro, cioè giudizi generali che l’intelletto produce a priori:
- gli assiomi dell’intuizione, il cui principio è che tutte le intuizioni sono quantità estensive;
- le anticipazioni della percezione, il cui principio stabilisce che in tutti i fenomeni la materia della sensazione è percepita secondo una quantità intensiva, cioè un grado;
- le analogie dell’esperienza, il cui principio generale stabilisce che l’esperienza è possibile solo mediante la rappresentazione di una connessione necessaria delle percezioni;
- e i postulati del pensiero empirico in generale, che distinguono tra ciò che è possibile, reale e necessario.
Tra questi principi i più importanti sono le analogie dell’esperienza che definiscono l’esperienza in quanto connessione di tutti i fenomeni in base a leggi necessarie. Appare quindi chiaro come l’esperienza si costituisca secondo le strutture dell’intelletto, il quale prescrive la sua legislazione alla natura. Ed è anche chiaro come per Kant la natura non sia la totalità delle sostanze in quanto cose in sé, come pensavano i metafisici del suo tempo. Alla fine dell’Analitica trascendentale, Kant si sofferma sulla definizione di noumeno, il quale, come vedremo, deve essere presupposto, ma non può essere conosciuto.

9. Fenomeno e noumeno

fenomeno e noumeno
Al termine dell’Analitica Kant fa il punto su uno dei concetti cardinali della sua filosofia: la distinzione tra il fenomeno e la cosa in sé (Ding an sich) o noumeno.
Gli oggetti dell’esperienza, come è noto, sono sempre fenomeni, cioè oggetti che ci sono dati nell’intuizione spazio-temporale.
La definizione stessa di fenomeno, però, quale oggetto come appare a noi, rinvia alle cose come sono in se stesse, indipendentemente dall’esperienza che noi ne abbiamo.
In quanto tali oggetti possono essere pensati dall’intelletto, ma mai conosciute attraverso l’intuizione sensibile, Kant dà loro il nome di noumeni, che significa appunto pensabili, intelligibili.
In relazione al noumeno, Kant sostiene che di tali enti, inconoscibili attraverso l’intuizione spazio-temporale, non possiamo avere conoscenza intellettuale, perché l’intelletto sintetizza i dati provenienti dall’intuizione, non li crea.
L’importanza del concetto di noumeno, allora, consiste proprio nel permetterci «di circoscrivere le pretese della sensibilità». Si tratta dunque di un concetto-limite che, senza fornirci conoscenze specifiche, permette di definire i limiti della conoscenza stessa.
Il mondo delle cose come sono in sé è dunque inattingibile. Resta dunque da considerare perché, di fatto, l’intelletto [o meglio, quella funzione dello spirito che Kant chiama “ragione”, distinguendola dall“‘intelletto” quale attività di unificazione dei dati sensibili] cerchi di oltrepassare tale limiti e di produrre conoscenza anche su questo mondo. Kant ne discute nella dialettica trascendentale.
10. La dialettica della ragione
10.1 La ragione pura come sede della parvenza trascendentale
Oltre alla sensibilità e all’intelletto, Kant indica nella ragione la terza facoltà conoscitiva, consistente nel pensiero che si applica agli oggetti che trascendono il mondo sensibile (noumeni), i quali, pur essendo inattingibili, costituiscono per noi la meta più alta e importante.
Kant paragona il territorio della verità conoscibile attraverso l’intelletto, a un’isola circondata
«da un oceano vasto e tempestoso, il vero e proprio sito della parvenza».

luna calante

luna sorgente
Egli chiama, infatti, parvenza trascendentale l’illusione, connaturata alla ragione umana, di varcare i limiti della conoscenza del mondo dei fenomeni e di accedere all’ambito metafisico.
Da questa esigenza nasce la dialettica della ragione, cioè l’arte di sviluppare ragionamenti contraddittori intorno al soprasensibile.
L’intelletto, infatti, si applica al materiale sensibile attraverso la mediazione dell’immaginazione, dandoci un’esperienza ordinata e strutturata. Il suo uso legittimo di unificazione del molteplice dà luogo alla conoscenza dei fenomeni, mentre il suo uso al di fuori di questa sfera è arbitrario e conduce ad antinomie.
La dialettica trascendentale si occupa, allora, della critica di questa illusione, nella consapevolezza che, così come l’ottica e l’astronomia non possono impedire all’occhio umano di percepire la luna sorgente più grande di quella calante, così la filosofia non può dissolvere la parvenza trascendentale e contrastare il bisogno metafisico della ragione verso l’incondizionato (cioè il sapere assoluto), ma semplicemente segnalarne l’esistenza e mettere in guardia gli uomini circa gli inganni della logica.
L’intelletto è finito, limitato, tuttavia è una caratteristica costitutiva del pensiero quella di voler afferrare la totalità:
ogni singola esperienza è infatti – spiega Kant – solo una parte di tutta la sfera dell’esperienza: la totalità assoluta di ogni esperienza possibile non è in se stessa un’esperienza e tuttavia è un problema necessario per la ragione. Prolegomeni, par. 40.
Come l’intelletto, anche la ragione ha carattere di spontaneità, ma si avvale di idee invece che di concetti (o categorie) e di sillogismi (inferenze logiche di una conclusione necessaria da due premesse) invece che di giudizi.

anima

Dio
Per esempio, davanti ad una connessione causale tra un certo numero di fenomeni, la ragione tenta di risalire alla causa ultima, a ciò che sia condizione senza essere a sua volta condizionato, attraverso le tre idee del mondo (la totalità dei fenomeni esterni), dell’anima (il soggetto assoluto, incondizionato) e di Dio (la condizione assoluta di ogni realtà): i tre campi d’indagine, appunto, della metafisica dogmatica, la cosmologia razionale, la psicologia razionale, la teologia razionale.
Tali tentativi sono però illusori, perché la ragione scambia per proprietà delle cose quelle che sono esigenze fondamentali del pensiero.
Ecco perché Kant definisce la dialettica una «logica della parvenza». La Dialettica trascendentale sarà dunque
«una critica dell’intelletto e della ragione rispetto al loro uso iperfisico».
quindi

10.2 La critica della cosmologia razionale e dell’idea del mondo come totalità

La critica all’idea di mondo
Nella Dialettica trascendentale, Kant mostra dunque come l’intelletto umano sia portato spontaneamente ad emettere una serie di proposizioni errate su oggetti che non possiamo esperire: il mondo come totalità, l’anima e Dio.
La cosmologia razionale si rivolge al mondo come alla totalità della condizione dei fenomeni.
In questo senso, il mondo è ben diverso dalla natura che è l’insieme dei fenomeni dell’esperienza legati da leggi. Kant mostra come l’illusione di conoscere il mondo come totalità (della quale nessuna esperienza è possibile) dia luogo ad antinomie, cioè coppie di proposizioni opposte, ognuna dimostrabile con argomenti di ugual forza.
Kant procede per assurdo, mostrando che se una proposizione è dimostrabile, il suo opposto non può essere possibile, perché ciò violerebbe il principio di non contraddizione.
In realtà, tale «scandalo della ragione» è solo apparente, perché le antinomie derivano dalla mancata distinzione tra fenomeno e cosa in sé. Se teniamo conto, infatti, che tutto ciò che intuiamo nello spazio e nel tempo è fenomeno, le domande sulla finitezza o infinità del mondo vengono a cadere.
L’idea di mondo dà origine secondo Kant, a quattro antinomie, così chiamate perché sono proposizioni opposte, davanti alle quali non si può dare ragione nella tesi né all’antitesi. Queste quattro antinomie sono quindi costituite da otto proposizioni opposte di cui è impossibile dimostrare la verità.
Le prime due, che Kant chiama antinomie matematiche, riguardano la finitezza o infinità del mondo e la sua divisibilità o indivisibilità. Ecco le prime due tesi:
Il mondo è finito nello spazio e nel tempo (ha un inizio e una fine), o il mondo è infinito nello spazio e nel tempo.
Ora, queste due proposizioni sono, per Kant, entrambe false, perché nel momento in cui affermiamo che il mondo è finito nello spazio nel tempo, o che è infinito nello spazio e nel tempo, applichiamo la categoria della qualità ad un oggetto che non possiamo esperire, cioè al mondo come totalità degli oggetti d’esperienza, mentre si è visto che le categorie si possono applicare solo a materiale sensibile.

Democrito
Lo stesso vale per l’altra coppia di antinomie relative alla divisibilità e indivisibilità del mondo, al problema cioè, se esistano degli elementi ultimi che non siano ulteriormente indivisibili, cioè alle tesi:
Ogni cosa è composta di parti semplici, non ulteriormente divisibili, non esistono parti semplici della materia, ogni cosa è complessa.
Anche in questo caso applichiamo la categoria della quantità in modo illegittimo cioè ad un ambito posto al di fuori della nostra esperienza.
In effetti, quello che possiamo dimostrare è che possiamo dividere ulteriormente delle particelle atomiche, in particelle più piccole ma non possiamo affermare con certezza fino a quando potremo continuare a dividerle e se raggiungeremo qualche elemento indivisibile. Quindi possiamo fare esperienza del fatto che dividiamo il mondo in parti sempre più piccole, ma non del fatto che queste parti non siano ulteriormente divisibili, perché per fare questo dovremmo compiere un’infinità di operazioni, ciò che è impossibile.

Epicuro (342 – 270 a.C.)
Quanto riguarda le antinomie dinamiche, queste possono essere formulate nel seguente modo:
il mondo è retto da leggi naturali o segue una causalità libera.
L’altra antinomia, invece, asserisce che
il mondo è totalmente contingente oppure che c’è un ente necessario che lo determina.
Analizziamo quindi la prima antinomia che Kant chiama dinamica perché riguarda la libertà, la contingenza e la serie delle cause, quindi il divenire. Per quanto riguarda la prima antinomia relativa all’esistenza di leggi naturali o di una causalità libera, possiamo dire che per Kant entrambe le proposizioni sono possibili, perché noi esperiamo il mondo attraverso le categorie dell’intelletto dominato da un’intrinseca necessità. Abbiamo visto, infatti, che tra le categorie dell’intelletto c’è quella di causa ed effetto che fa sì che noi viviamo l’esperienza come necessaria perché determinata da cause.
Tuttavia il fatto di esperire in questo modo la realtà fenomenica, non impedisce che al di fuori di essa vi sia una causalità libera, una causalità non costrittiva che debba sottostare alla necessità. Avvertiamo questo soprattutto in ambito morale perché nel momento in cui agiamo in vista di un un fine, o di un bene noi ci sentiamo liberi di agire e non costretti da fattori esterni o comunque anche se costretti sentiamo in noi sempre un margine di libertà. E quindi le prime due proposizioni di questa antinomia dinamica possono essere entrambe vere.
Passiamo adesso alla seconda antinomia sulla contingenza e la necessità. Certo noi esperiamo la realtà come qualcosa anche di contingente, perché sappiamo che tutto ciò che è potrebbe anche non essere, non accadere, tuttavia, afferma Kant, potremmo pensare che al di fuori dell’ambito fenomenico esista un ente necessario che determina la realtà così come noi la esperiamo, e quindi ancora una volta, Kant ritiene che queste proposizioni possono essere entrambe vere. Queste sono dunque le coppie di antinomie che generano l’idea di mondo.
Vediamo come Kant stia contestando la metafisica tradizionale, perché nel momento in cui le categorie non possono essere applicate a materiale non sensibile, cioè a materiale non fenomenico, è chiaro che tutte le tesi filosofiche che si pronunciano sull’essenza della realtà, sull’essenza dell’anima e sull’essenza del mondo, risultano illusorie e indimostrabili. Quindi è l’intera metafisica tradizionale che va a cadere e deve essere sostituita da un’altra metafisica come quella kantiana che è in realtà una gnoseologia che determina i limiti della ragione e della conoscenza piuttosto che l’essenza della realtà.
Nonostante queste idee illusorie siano prodotte spontaneamente dalla ragione, ciò non significa per Kant che siamo costretti ad illuderci per sempre. Ecco perché il filosofo smaschera questi ragionamenti falsi per restringere la validità e la portata di queste idee. L’idea di mondo infatti può essere importante dal punto di vista conoscitivo. Infatti, se è vero che non possiamo pronunciarci sull’essenza del mondo, è vero anche che in ambito scientifico, l’idea di mondo è un’idea regolativa molto importante perché se non l’avessimo non saremmo portati a cercare un’unità nella molteplicità disordinata dell’apparire fenomenico.
10.3 La critica della psicologia razionale e dell’idea dell’anima come sostanza eterna e incorruttibile
Al tempo di Kant, la psicologia razionale era una disciplina metafisica che pretendeva, in continuità con la tradizione platonica, di dimostrare la sostanzialità, la semplicità, la personalità e l’immortalità dell’anima.
di Kant, la psicologia razionale era una disciplina metafisica che pretendeva, in continuità con la tradizione platonica, di dimostrare la sostanzialità, la semplicità, la personalità e l’immortalità dell’anima.
In particolare, i dogmatici, affermavano che l’anima era una sostanza semplice, non ulteriormente scomponibile, dunque incorruttibile, che permane identica a se stessa nel tempo.
Kant mostra come gli psicologi razionali basino le loro deduzioni su sillogismi formalmente scorretti.
Un sillogismo, infatti, è un ragionamento in cui il legame tra due concetti (A e C) è stabilito per mezzo di un termine medio (B). Se però quest’ultimo è assunto in due significati differenti nelle due premesse, si genera un paralogismo, cioè un ragionamento falso la cui conclusione è corretta solo in apparenza.
Il fondamentale paralogismo della psicologia razionale è quello che identifica il soggetto razionale con una sostanza, cioè l’anima, da cui ricava con altre deduzioni i caratteri per cui essa è semplice, incorruttibile e dunque immortale.
La psicologia razionale scambia, poi, l’attività di unificazione del molteplice (l’Io penso) – che non è un oggetto, ma la condizione di pensabilità degli oggetti, cioè un fattore trascendentale – con una cosa in sé.
Vediamo il funzionamento del paralogismo:
Tutto ciò che è solo soggetto è sostanza, l’Io penso è solo soggetto, dunque l’Io penso è sostanza.

Cartesio (1596 – 1650)
Kant evidenzia in proposito che l’anima non può essere pensata come una sostanza, perché la categoria di sostanza non è applicabile alla soggettività, visto che la soggettività non è un oggetto fenomenico che noi esperiamo.
Ciò significa che per Kant Cartesio ha torto a parlare della soggettività come res cogitans, cioè come la sostanza pensante, proprio perché quella di sostanza è una categoria che si può applicare solo materiale sensibile informato dallo spazio e dal tempo.
Invece per Kant, la soggettività può essere pensata soltanto come qualcosa che accompagna ogni percezione, esperienza o vissuto.
Vale a dire che ogni volta che percepiamo un oggetto questa percezione è accompagnata dalla percezione che lo stiamo percependo o dal ricordo che lo abbiamo percepito, cioè che sappiamo di percepire o di ricordare. Quindi, da una parte la direzione della soggettività è verso l’oggetto: essa pensa, ma è anche presente un’altra direzione, autoriflessiva che è fondamentale in ogni percezione, perché non soltanto noi pensiamo dei contenuti ma sappiamo anche di pensare i contenuti. E’ questo l’Io penso: un movimento autoriflessivo della soggettività che accompagna ogni nostra percezione.
Come nasce allora l’illusione di una soggettività immutabile ed eterna (tutto ciò che è solo soggetto è sostanza, poiché l’Io penso è solo soggetto, esso è dunque sostanza)?

Aristotele (384/83 – 322 a.C.)
L’errore, osserva Kant, è che il termine soggetto è inteso nella prima premessa e nella seconda premessa in due modi diversi.
Prima di tutto quando diciamo che tutto ciò che è soggetto è solo sostanza, intendiamo (nella prima premessa) il soggetto inteso in senso grammaticale: è chiaro che tutto ciò che è soggetto, e solo soggetto, può essere chiamato sostanza nel senso che non può occupare la posizione di predicato.
Infatti già nella definizione di Aristotele, la sostanza è ciò che non potrà mai avere funzione di predicato, cioè ciò di cui si può predicare qualcosa, ma che non può mai essere il predicato di qualcosa. Perciò nella prima premessa, si intende la sostanza in senso grammaticale.
Nella seconda premessa invece quella secondo cui l’io penso è solo soggetto, si intende invece l’attività dell’Io penso, cioè il movimento auto-riflessivo di cui si parlava sopra, presente in ogni percezione e in ogni vissuto.
Quindi la prima premessa si riferisce al soggetto in senso grammaticale mentre la seconda si riferisce al soggetto come funzione trascendentale, cioè come attività di sintesi del molteplice dell’esperienza, l’attività, appunto, dell’Io penso. È chiaro allora che siamo di fronte a un falso sillogismo (un paralogismo) e che la conclusione: “l’Io penso è sostanza” è una conclusione evidentemente errata, perché il termine “soggetto” delle due premesse non può avere un termine medio, proprio perché inteso in due modi diversi.
È una conclusione errata che porta però ad una grave illusione, consistente nel considerare l’Io penso come un oggetto, una cosa, una sostanza eterna ed immutabile.
Nonostante l’illusorietà del concetto di anima, anch’esso può avere un uso regolativo, perché quando agiamo dobbiamo sempre sentirci come una soggettività libera. Kant farà un uso regolativo del concetto di anima nella Critica della ragion pratica, quando offrirà un’argomentazione sull’esistenza dell’anima che non ha più alcuna intenzione dimostrativa, ha cioè un valore etico, non metafisico.
Siamo adesso alle illusioni legate alla dimostrazione dell’idea di Dio.
Nella dialettica trascendentale Kant critica sia le prove ontologiche che le prove cosmologiche.
La critica funziona sempre nello stesso modo: nel caso della prova ontologica, applichiamo in modo illecito la categoria di esistenza, così come nelle prove cosmologiche applichiamo arbitrariamente la categoria di causa ed effetto.

10.4 La critica della teologia razionale e delle prove dell’esistenza di Dio
 Nell’idea di Dio (teologia razionale) la ragione esprime invece il concetto di un essere supremo, originario, perfetto ed eterno che rappresenta il prototipo di perfezione a cui ogni cosa esistente viene commisurata, secondo diversi gradi di vicinanza ad essa.
Nell’idea di Dio (teologia razionale) la ragione esprime invece il concetto di un essere supremo, originario, perfetto ed eterno che rappresenta il prototipo di perfezione a cui ogni cosa esistente viene commisurata, secondo diversi gradi di vicinanza ad essa.
L’illusione della ragione consiste nel trasformare questo concetto ideale, questo ente di ragione, in una realtà. Il criticismo kantiano nega pertanto che si possa avere conoscenza teoretica di Dio.
I filosofi moderni, Cartesio, Leibniz Spinoza, hanno semplificato la formulazione della prova ontologica di sant’Anselmo, notando che Dio è l’essere che ha in sé tutte le perfezioni, l’esistenza è una perfezione dunque Dio deve necessariamente esistere.
Ciò che è errato in questa dimostrazione è, per Kant, il pensare l’esistenza come una perfezione, cioè una qualità che si aggiunga all’essenza di Dio, ma ciò non è vero, perché il concetto di qualcosa è sempre perfetto anche se manca d’esistenza. L’esistenza non aggiunge niente al concetto: 100 talleri sono sempre 100 talleri e non 99, sia che li pensi o che li abbia in tasca.
L’esistenza inoltre non è qualcosa che può essere predicato, ma essendo la capacità di una cosa di essere oggetto d’esperienza per qualcuno, può essere solo constatata empiricamente.
Anche i ragionamenti cosmologici circa l’esistenza di Dio sono errati.
Nelle dimostrazioni cosmologiche, a posteriori, abbiamo infatti un ragionamento di questo tipo: ogni effetto dipende da una causa, ma non si può risalire all’infinito la catena delle cause e degli effetti, quindi si deve supporre una causa prima e la causa prima di ogni cosa è Dio.
Anche in questo caso, applichiamo la categoria di causalità alla totalità dei fenomeni, ma la totalità dei fenomeni non è conoscibile, dunque non possiamo applicare la categoria di causa effetto a ciò che è oltre i confini dell’esperienza. Come vedremo, anche l’idea di Dio verrà recuperata da Kant a livello morale.
11. L’etica kantiana
11.1 L’autonomia dell’etica dalla religione

La religione nei limiti della sola ragione, censurato da Federico Guglielmo II nel 1794
La concezione kantiana della religione è contenuta, oltre che in una serie di scritti minori, ne La religione entro i limiti della sola ragione, pubblicata dopo molte difficoltà nel 1793 e oggetto della famosa lettera con cui Federico Guglielmo II intimava al filosofo di cessare i suoi studi in materia di religione.
In questo testo Kant pone le basi per la distinzione tra religione ed etica, analizzando la differenza tra religione rivelata (o positiva, cioè la fede oggetto di culto) e religione naturale (quella basata sulla ragione) e sostenendo che non è possibile avere di Dio alcuna conoscenza oggettiva ma che, d’altra parte, l’esistenza di Dio è un’esigenza della ragion pratica: Dio è dunque oggetto di una fede morale-razionale.
« La religione in cui io devo, prima, sapere che qualche cosa è un comando divino, per riconoscerla poi come mio dovere, è la religione rivelata (o che esige una rivelazione): quella, invece, in cui io devo sapere che qualche cosa è un dovere prima che la possa riconoscere come un comando divino, è la religione naturale » [ Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, IV].
La riflessione di Kant si indirizza quindi, più che sull’esistenza di Dio, sul rapporto tra religione e morale, ribadendo che
la morale non ha bisogno dell’idea di un essere superiore all’uomo, quando questi conosca il suo dovere.
Essa, dunque, basta a se stessa.

11.2 La natura umana
L’indagine kantiana sulla morale prende avvio dall’osservazione della natura dell’uomo che permette di constatare una propensione umana al bene, testimoniata dall’esistenza della legge morale, accanto ad una ineliminabile inclinazione al male, che Kant chiama il «male radicale».
Va sottolineato che con il termine «natura umana» Kant intende esclusivamente (con Pascal) il fondamento soggettivo dell’uso della libertà. Dire che l’uomo ha un’inclinazione radicale al male non significa dunque che sia vittima di una forza estranea alla sua volontà, né identificare il male con un istinto naturale (non valutabile in termini morali).
Il male radicale è invece quella tendenza, dovuta alla finitezza umana, ad adottare comportamenti contrari alla legge morale, pur essendo consapevoli di questa. La cattiveria è dunque una scelta di libertà che antepone alla legge morale l’amor di sé.

11.3 Il compito della filosofia morale

1785

1788
Il compito della filosofia della morale, a cui Kant dedica la Fondazione della metafisica dei costumi (1785) e la Critica della ragion pratica (1788), non è, per per il filosofo, quello di costruire un sistema di valori, ma di compiere un’indagine critica sui fondamenti della morale.
Infatti, obbedire a dei precetti, cioè a una serie di indicazioni prestabilite (“fai questo”, “non fare quello” ..), non è sempre una via sicura al comportamento giusto, come evidenzia l’esempio di Alessandro Gelain nel video sottostante
11.4 Un’etica formale
Come la Critica della ragion pura si era occupata delle condizioni di possibilità della conoscenza, si tratta, in questo caso, di indagare la forma della legge morale, non i singoli precetti.
Una legge è infatti tale per la sua forma, non per ciò che prescrive (il suo contenuto). La legge morale è quindi quella che esprime un’obbligazione universale (cioè che vale per tutti) e necessaria (cioè che vale in ogni caso).
11.5 Le massime della volontà
Come si è accennato, non esiste legge morale senza libertà e ragione (ci sarebbero in tal caso comportamenti necessari, non qualificabili come buoni o cattivi).
E’ attraverso di esse che la volontà si determina (cioè decide le azioni e i comportamenti degli individui). Kant chiama massime, quei principi pratici, ovvero quelle determinazioni della volontà individuale che valgono solo per il singolo individuo (per esempio, un individuo può darsi la massima per cui l’obiettivo delle proprie azioni è la felicità).
11.6 Il dovere e l’imperativo morale
Non siamo ancora in presenza di una legge morale perché è dubbio che essa debba valere per tutti e in ogni caso. Si ha invece legge morale quando il soggetto si rende conto che una certa azione è doverosa cioè lo obbliga al rispetto (tu devi), indipendentemente dal suo contenuto.
In un essere assolutamente razionale la massima soggettiva coinciderebbe immediatamente con la legge morale e con il suo comportamento – in questo caso avremmo non una volontà buona, ma santa -, nell’uomo invece la coincidenza tra massima e legge non può che consistere nella subordinazione delle massime alla legge, cioè nell’obbedienza all’imperativo morale.

11.7 L’imperativo categorico e le sue formulazioni
L’imperativo è in Kant il dovere che si esprime nella forma dell’obbligazione. Il filosofo distingue tra imperativi ipotetici e imperativi categorici: gli imperativi ipotetici rappresentano la necessità di un’azione come mezzo per raggiungere qualche altro fine. Si agisce bene, sotto il comando dell’imperativo ipotetico quando i mezzi sono adeguati ai fini: se vuoi x fai y. L’imperativo categorico, invece, il vero imperativo morale, non ha come obiettivo un fine particolare, ma dichiara l’azione come necessaria per se stessa.
«Agisci sempre in modo che la massima della tua volontà possa valere nello stesso tempo come principio di legislazione universale». Critica della ragion pratica
«Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona che in quella di chiunque altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo». Fondazione della metafisica dei costumi
Agisci in modo che «la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice». Fondazione della metafisica dei costumi.
«Il dovere è la necessità di un‘azione per rispetto della legge».
 Di qui l‘autonomia della volontà: l’uomo, in quanto essere razionale, è legge a se stesso.
Di qui l‘autonomia della volontà: l’uomo, in quanto essere razionale, è legge a se stesso.

La tomba di Kant nella cattedrale di Kaliningrad che reca scolpito il passo della Critica della Ragion pratica « Due cose riempiono la mente con sempre nuova e crescente ammirazione e rispetto, tanto più spesso e con costanza la riflessione si sofferma su di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me ».
Il concetto della libertà ci permette di non uscire fuori di noi per trovare l’incondizionato: il cielo stellato sopra di me […] la legge morale in me.
Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto piú spesso e piú a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell’oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza.
La prima comincia dal posto che io occupo nel mondo sensibile esterno, ed estende la connessione in cui mi trovo a una grandezza interminabile, con mondi e mondi, e sistemi di sistemi; e poi ancora ai tempi illimitati del loro movimento periodico, del loro principio e della loro durata. La seconda comincia dal mio io indivisibile, dalla mia personalità, e mi rappresenta in un mondo che ha la vera infinitezza, ma che solo l’intelletto può penetrare, e con cui (ma perciò anche in pari tempo con tutti quei mondi visibili) io mi riconosco in una connessione non, come là, semplicemente accidentale, ma universale e necessaria.
Il primo spettacolo di una quantità innumerevole di mondi annulla affatto la mia importanza di creatura animale che deve restituire al pianeta (un semplice punto nell’Universo) la materia della quale si formò, dopo essere stata provvista per breve tempo (e non si sa come) della forza vitale.
Il secondo, invece, eleva infinitamente il mio valore, come [valore] di una intelligenza, mediante la mia personalità in cui la legge morale mi manifesta una vita indipendente dall’animalità e anche dall’intero mondo sensibile, almeno per quanto si può riferire dalla determinazione conforme ai fini della mia esistenza mediante questa legge: la quale determinazione non è ristretta alle condizioni e ai limiti di questa vita, ma si estende all’infinito [Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198].
12. La Critica del giudizio
Kant vede opposizione tra la sfera conoscitiva (ragion pura) e quella morale (ragion pratica): la prima infatti è dominata dalla necessità, nella seconda invece regna la libertà. Nella Critica del giudizio si chiede quindi se è possibile postulare una sfera che trascenda senza armonizzarle queste due realtà. Per fare questo Kant mette in gioco una terza facoltà presente nell’uomo: il sentimento.
 Kant considera il sentimento sotto due aspetti, in quanto sentimento del bello e del sublime (estetica) – il termine è usato qui da Kant con significato diverso rispetto alla CRP nella quale identificava il discorso sulla sensazione e sulle sue forme pure – e in quanto sentimento di una armonia complessiva della natura, cioè il sentimento che le cose non ci sono per caso ma rispondono ad una finalità (teleologia).
Kant considera il sentimento sotto due aspetti, in quanto sentimento del bello e del sublime (estetica) – il termine è usato qui da Kant con significato diverso rispetto alla CRP nella quale identificava il discorso sulla sensazione e sulle sue forme pure – e in quanto sentimento di una armonia complessiva della natura, cioè il sentimento che le cose non ci sono per caso ma rispondono ad una finalità (teleologia).
 Kant inizia a riflettere del sentimento del bello attraverso la descrizione dei giudizi (anche qui i giudizi sentimentali sono diversi dai giudizi conoscitivi) che Kant distingue in determinanti e riflettenti. I giudizi determinanti sono quelli scientifici descritti nella prima critica, mentre i giudizi riflettenti sono giudizi del sentimento in cui non applichiamo le categorie e mettiamo in gioco il sentimento estetico che coglie l’armonia e l’intima finalità delle cose.
Kant inizia a riflettere del sentimento del bello attraverso la descrizione dei giudizi (anche qui i giudizi sentimentali sono diversi dai giudizi conoscitivi) che Kant distingue in determinanti e riflettenti. I giudizi determinanti sono quelli scientifici descritti nella prima critica, mentre i giudizi riflettenti sono giudizi del sentimento in cui non applichiamo le categorie e mettiamo in gioco il sentimento estetico che coglie l’armonia e l’intima finalità delle cose.
Secondo Kant, anche i giudizi riflettenti, i giudizi del sentimento, hanno una loro universalità. Kant tiene a distinguere il piacevole che vale solo per uno, dal bello che è oggettivo, trascendentale, cioè uguale per tutti. Quello del bello è infatti «un giudizio universale senza concetto». In altre parole, secondo Kant, tutti i soggetti conoscono, vogliono e sentono attraverso forme pure a priori, di qui l’universalità della conoscenza, della legge morale e del sentimento del bello.
 Il bello, dice Kant, è ciò che piace universalmente senza interesse. Ciò che lo distingue dal sublime è che il bello ha a che fare con la misura e l’armonia, mentre il sublime con lo smisurato. Questo sentimento dello smisurato può essere il sublime di grandezza, in cui ci si perde (ad esempio, il cielo stellato) e il sublime di potenza (per esempio, il mare in tempesta, la forza della natura scatenata). In che senso dà un senso di piacere universale? Da un lato ci sentiamo piccoli rispetto a questa grandezza a questa smisuratezza o di grandezza o di potenza, ma successivamente consideriamo che siamo noi a guardare: l’uomo è misero ma è colui che ammira, è colui che vede questo che altrimenti sarebbe un avvenimento di cui nessuno avrebbe coscienza
Il bello, dice Kant, è ciò che piace universalmente senza interesse. Ciò che lo distingue dal sublime è che il bello ha a che fare con la misura e l’armonia, mentre il sublime con lo smisurato. Questo sentimento dello smisurato può essere il sublime di grandezza, in cui ci si perde (ad esempio, il cielo stellato) e il sublime di potenza (per esempio, il mare in tempesta, la forza della natura scatenata). In che senso dà un senso di piacere universale? Da un lato ci sentiamo piccoli rispetto a questa grandezza a questa smisuratezza o di grandezza o di potenza, ma successivamente consideriamo che siamo noi a guardare: l’uomo è misero ma è colui che ammira, è colui che vede questo che altrimenti sarebbe un avvenimento di cui nessuno avrebbe coscienza  o consapevolezza, quindi è colui che può dare un senso ad uno spettacolo che altrimenti sarebbe un cozzare meccanico di elementi. E’ solo l’uomo che ammira il cielo, è solo l’uomo che ammira il mare in tempesta.
o consapevolezza, quindi è colui che può dare un senso ad uno spettacolo che altrimenti sarebbe un cozzare meccanico di elementi. E’ solo l’uomo che ammira il cielo, è solo l’uomo che ammira il mare in tempesta.
Il giudizio teleologico è il giudizio che percepisce un’armonia in un oggetto vivente o anche nell’intera natura. Esso implica il vedere le cose viventi o la natura nel suo insieme come se fosse dovuta ad un piano intelligente, da un intelligenza diversa della nostra, superiore alla nostra.
In conclusione, si è visto che il problema iniziale della critica del giudizio è di gettare un ponte tra ragion pura e ragion pratica, tra la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica cioè tra la necessità e la libertà. Kant lo individua già nell’opera d’arte, quale opera libera e creativa di un autore che però ha una sua necessità (perché se cambiassi anche il minimo particolare il tutto sarebbe stonato), ma soprattutto nel giudizio teleologico, nel quale possiamo immaginare la natura come qualcosa di armonico che lega tutti gli esseri, dalla natura inorganica ai primi organismi vegetali, fino a quelli più complessi e, al culmine di questa scala, l’uomo, sintesi in se stesso di libertà e necessità.
13. Gli scritti politici. La Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?
I. Kant, Beantwortung der Frage: Was is Aufklaerung? in “Berlinische Monatsschrift”, I-V, 1784 (5 dicembre 1783), pp. 481-94.
L’intelletto quale guida

Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro
L’illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza esser guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza – è dunque il motto dell’illuminismo.
La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo affrancati dall’eterodirezione (naturaliter maiorennes), tuttavia rimangono volentieri minorenni per l’intera vita e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro tutori. E’ tanto comodo essere minorenni! Se ho un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che decide per me sulla dieta che mi conviene, ecc., io non ho più bisogno di darmi pensiero per me. Purché io sia in grado di pagare, non ho bisogno dì pensare: altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione.

mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole
A far si che la stragrande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltreché difficile, anche molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra costoro. Dopo averli in un primo tempo instupiditi come fossero animali domestici e aver accuratamente impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dei girello da bambini in cui le hanno imprigionate, in un secondo tempo mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora questo pericolo non è poi così grande come loro si fa credere, poiché a prezzo di qualche caduta essi alla fine imparerebbero a camminare: ma un esempio di questo genere rende comunque paurosi e di solito distoglie la gente da ogni ulteriore tentativo. È dunque difficile per ogni singolo uomo districarsi dalla minorità che per lui è diventata pressoché una seconda natura. E’ giunto perfino ad amarla, e attualmente è davvero incapace di servirsi del suo proprio intelletto, non essendogli mai stato consentito di metterlo alla prova. Regole e formule, questi strumenti meccanici di un uso razionale o piuttosto di un abuso delle sue disposizioni naturali, sono ceppi di una eterna minorità. Anche chi da essi riuscisse a sciogliersi, non farebbe che un salto malsicuro sia pure sopra i più angusti fossati, poiché non sarebbe allenato a siffatti liberi movimenti. Quindi solo pochi sono riusciti, con l’educazione del proprio spirito, a districarsi dalla minorità e tuttavia a camminare con passo sicuro.
La vocazione della ragione all’autonomia

Che un pubblico si illumini da sé è quasi inevitabile, se gli si lascia la libertà .. la vocazione di ogni uomo a pensare da sé
Che invece un pubblico si illumini da sé è cosa maggiormente possibile; e anzi, se gli si lascia la libertà, è quasi inevitabile. In tal caso infatti si troveranno sempre, perfino fra i tutori ufficiali della grande folla, alcuni liberi pensatori che, dopo aver scosso da sé il giogo della tutela, diffonderanno il sentimento della stima razionale del proprio valore e della vocazione di ogni uomo a pensare da sé. V’è al riguardo il fenomeno singolare che il pubblico, il quale in un primo tempo è stato posto da costoro sotto quel giogo, li obbliga poi esso stesso a rimanervi, non appena lo abbiano a ciò istigato quelli tra i suoi tutori che fossero essi stessi incapaci di ogni lume. Seminare pregiudizi è tanto pericoloso, proprio perché essi finiscono per ricadere sui loro autori o sui predecessori dei loro autori. Perciò il pubblico può giungere al rischiaramento solo lentamente. Forse una rivoluzione potrà sì determinare l’affrancamento da un dispotismo personale e da un’oppressione avida di guadagno e di potere, ma mai una vera riforma del modo di pensare. Al contrario: nuovi pregiudizi serviranno al pari dei vecchi a guidare ciecamente la moltitudine che non pensa. Senonché a questo rischiaramento non occorre altro che la libertà; e precisamente la più inoffensiva di tutte le libertà, quella cioè di fare pubblico uso della propria ragione in tutti i campi.
Ma da tutte le parti odo gridare: non ragionate! L’ufficiale dice: non ragionate, ma fate esercitazioni militari! L’intendente di finanza: non ragionate, ma pagate! L’ecclesiastico: non ragionate, ma credete! (C’è solo un unico signore al mondo che dice: ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete, ma obbedite!) Qui v’è, dovunque, limitazione della libertà. Ma quale limitazione è d’ostacolo all’illuminismo, e quale non lo è, anzi lo favorisce? Io rispondo: il pubblico uso della propria ragione dev’essere libero in ogni tempo, ed esso solo può attuare il rischiaramento tra gli uomini; invece l’uso privato della ragione può assai di frequente subire strette limitazioni senza che il progresso del rischiaramento ne venga particolarmente ostacolato. Intendo per uso pubblico della propria ragione l’uso che uno ne fa, come studioso, davanti all’intero pubblico dei lettori.
Chiamo invece uso privato della ragione quello che ad un uomo è lecito farne in un certo ufficio o funzione civile di cui egli è investito. Ora per molte operazioni che attengono all’interesse della comunità è necessario un certo meccanicismo, per cui alcuni membri di essa devono comportarsi In modo puramente passivo onde mediante un’armonia artificiale il governo induca costoro a concorrere ai fini comuni o almeno a non contrastarli. Qui ovviamente non è consentito ragionare ma si deve obbedire. Ma in quanto nello stesso tempo questi membri della macchina governativa considerano se stessi come membri di tutta la comunità e anzi della società cosmopolitica, e si trovano quindi nella qualità di studiosi che con gli scritti si rivolgono a un pubblico nel senso proprio della parola, essi possono certamente ragionare senza ledere con ciò l’attività cui sono adibiti come membri parzialmente passivi. Così sarebbe assai pernicioso che un ufficiale, cui fu dato un ordine dal suo superiore, volesse in servizio pubblicamente ragionare sull’opportunità e utilità di questo ordine: egli deve obbedire. Ma è iniquo impedirgli in qualità di studioso di fare le sue osservazioni sugli errori commessi nelle operazioni di guerra e di sottoporle al giudizio del suo pubblico. Il cittadino non può rifiutarsi di pagare i tributi che gli sono imposti; e un biasimo inopportuno di tali imposizioni, quando devono essere da lui eseguite, può anzi venir punito come uno scandalo (poiché potrebbe indurre a disubbidienze generali). Tuttavia costui non agisce contro il dovere di cittadino se, come studioso, manifesta apertamente il suo pensiero sulla sconvenienza o anche sull’ingiustizia di queste imposizioni.
L’uso privato della ragione
Così un ecclesiastico è tenuto a insegnare il catechismo agli allievi e alla sua comunità religiosa secondo il credo della Chiesa da cui dipende perché a questa condizione egli è stato assunto: ma come studioso egli ha piena libertà e anzi il compito di comunicare al pubblico tutti i pensieri che un esame severo e benintenzionato gli ha suggerito circa i difetti di quel credo, nonché le sue proposte di riforme della religione e della Chiesa. In ciò non v’è nulla di cui la coscienza possa venir incolpata. Ciò ch’egli insegna in conseguenza del suo ufficio, come funzionario della Chiesa, egli infatti lo espone come qualcosa intorno a cui non ha la libertà di insegnare secondo le sue proprie idee, ma che ha il compito di insegnare secondo le istruzioni e nel nome di un altro. Egli dirà: la nostra Chiesa insegna questo e quello, e queste sono le prove di cui essa si vale. Tutta l’utilità pratica che alla sua comunità religiosa può derivare, egli dunque la ricaverà da principi ch’egli stesso non sottoscriverebbe con piena convinzione, ma al cui Insegnamento può comunque impegnarsi perché non è affatto impossibile che in essi non si celi una qualche verità, e in ogni caso, almeno, non si riscontra in essi nulla che contraddica alla religione interiore. Se invece credesse di trovarvi qualcosa che vi contraddica, egli non potrebbe esercitare la sua funzione con coscienza; dovrebbe dimettersi. L’uso che un insegnante ufficiale fa della propria ragione davanti alla sua comunità religiosa è dunque solo un uso privato; e ciò perché quella comunità, per quanto grande sia, è sempre soltanto una riunione domestica; e sotto questo rapporto egli, come prete, non è libero e non può neppure esserlo, poiché esegue un incarico che gli viene da altri. Invece come studioso che parla con gli scritti al pubblico propriamente detto, cioè al mondo, dunque come ecclesiastico nell’uso pubblico della propria ragione, egli gode di una libertà illimitata di valersi della propria ragione e di parlare in persona propria. Che i tutori del popolo (nelle cose spirituali) debbano a loro volta rimanere sempre minorenni, è un’assurdità che tende a perpetuare le assurdità.
Limiti degli impegni collettivi
Ma una società di ecclesiastici, ad esempio un’assemblea chiesastica o una venerabile “classe” (come essa si autodefinisce presso gli olandesi), avrebbe forse il diritto di obbligarsi per giuramento a un certo credo religioso immutabile, per esercitare in tal modo sopra ciascuno dei suoi membri, e attraverso essi, sul popolo, una tutela continua, e addirittura per rendere eterna questa tutela? Io dico che ciò è affatto impossibile. Un tale contratto, teso a tener lontana l’umanità per sempre da ogni ulteriore progresso nel rischiaramento, è irrituale e nullo in maniera assoluta, foss’anche che a sancirlo siano stati il potere sovrano, le Diete imperiali e i più solenni trattati di pace.
Nessuna epoca può collettivamente impegnarsi con giuramento a porre l’epoca successiva in una condizione che la metta nell’impossibilità di estendere le sue conoscenze (soprattutto se tanto necessarie), di liberarsi dagli errori e in generale di progredire nel rischiaramento. Ciò sarebbe un crimine contro la natura umana, La cui originaria destinazione consiste proprio in questo progredire; e quindi le generazioni successive sono perfettamente legittimate a respingere quelle convenzioni come non autorizzate ed empie. La pietra di paragone di tutto ciò che può imporsi come legge a un popolo sta nel quesito se un popolo possa imporre a se stesso una tale legge. Ciò sarebbe sì una cosa possibile, per così dire in attesa di una legge migliore e per un breve tempo determinato, al fine di introdurre un certo ordine, ma purché nel frattempo si lasci libero ogni cittadino, soprattutto l’uomo di Chiesa, di fare sui difetti dell’istituzione vigente le sue osservazioni pubblicamente, nella sua qualità di studioso, cioè mediante i suoi scritti; e ciò mentre l’ordinamento costituito resterà pur sempre in vigore fino a che le nuove vedute in questa materia non abbiano raggiunto nel pubblico tanta diffusione e credito che i cittadini, con l’unione dei loro voti (anche se non di tutti) siano in grado di presentare al sovrano una proposta tesa a proteggere quelle comunità che fossero d’accordo per un mutamento in meglio nella costituzione religiosa secondo le loro idee, e senza pregiudizio per quelle comunità che invece intendessero rimanere nell’antica costituzione.
Ma concentrarsi per mantenere in vigore, foss’anche per la sola durata della vita di un uomo, una costituzione religiosa immutabile che nessuno possa pubblicamente porre in dubbio, e con ciò annullare per così dire una fase cronologica del cammino dell’umanità verso il suo miglioramento e rendere questa fase sterile e per ciò stesso forse addirittura dannosa alla posterità, questo non è assolutamente lecito. Un uomo può si per la propria persona, e anche in tal caso solo per un certo tempo, differire di illuminarsi su ciò ch’egli stesso è tenuto a sapere; ma rinunciarvi per sè e più ancora per la posterità, significa violare e calpestare i sacri diritti dell’umanità. Ora ciò che neppure un popolo può decidere circa se stesso, lo può ancora meno un monarca circa il popolo; infatti il suo prestigio legislativo si fonda precisamente sul fatto che nella sua volontà egli riassume la volontà generale del popolo.
 Purché egli badi che ogni vero o presunto miglioramento non contrasti con l’ordinamento civile, egli non può per il resto che lasciare i suoi sudditi liberi di fare quel che credono necessario per la salvezza della loro anima. Ciò non lo riguarda affatto, mentre quel che lo riguarda è di impedire che l’uno ostacoli con la violenza l’altro nell’attività che costui, con tutti i mezzi che sono in suo potere, esercita in vista dei propri fini e per soddisfare le proprie esigenze. Il monarca reca detrimento alla sua stessa maestà se si immischia in queste cose ritenendo che gli scritti nei quali i suoi sudditi mettono in chiaro le loro idee siano passibili di controllo da parte del governo: sia ch’egli faccia ciò invocando il proprio intervento autocratico ed esponendosi al rimprovero che Caesar non est supra grammaticos, sia, e a maggior ragione, se egli abbassa il suo potere supremo tanto da sostenere il dispotismo spirituale di qualche tiranno nel suo Stato contro tutti gli altri suoi sudditi.
Purché egli badi che ogni vero o presunto miglioramento non contrasti con l’ordinamento civile, egli non può per il resto che lasciare i suoi sudditi liberi di fare quel che credono necessario per la salvezza della loro anima. Ciò non lo riguarda affatto, mentre quel che lo riguarda è di impedire che l’uno ostacoli con la violenza l’altro nell’attività che costui, con tutti i mezzi che sono in suo potere, esercita in vista dei propri fini e per soddisfare le proprie esigenze. Il monarca reca detrimento alla sua stessa maestà se si immischia in queste cose ritenendo che gli scritti nei quali i suoi sudditi mettono in chiaro le loro idee siano passibili di controllo da parte del governo: sia ch’egli faccia ciò invocando il proprio intervento autocratico ed esponendosi al rimprovero che Caesar non est supra grammaticos, sia, e a maggior ragione, se egli abbassa il suo potere supremo tanto da sostenere il dispotismo spirituale di qualche tiranno nel suo Stato contro tutti gli altri suoi sudditi.
L’età dell’Illuminismo

L’età dell’illluminismo, o il secolo di Federico
Se ora si domanda: viviamo noi attualmente in un’età illuminata? allora la risposta è: no, bensì in un’età di illuminismo. Che nella situazione attuale gli uomini presi in massa siano già in grado, o anche solo possano essere posti in grado di valersi sicuramente e bene del loro proprio intelletto nelle cose della religione, senza la guida di altri, è una condizione da cui siamo ancora molto lontani. Ma che ad essi, adesso, sia comunque aperto il campo per lavorare ad emanciparsi verso tale stato, e che gli ostacoli alla diffusione del generale rischiaramento o all’uscita dalla minorità a loro stessi imputabile a poco a poco diminuiscano, di ciò noi abbiamo invece segni evidenti.
A tale riguardo quest’età è l’età dell’illuminismo, o il secolo di Federico. Un principe che non crede indegno di sé dire che considera suo dovere non prescrivere nulla agli uomini nelle cose di religione, ma lasciare loro in ciò piena libertà, e che quindi respinge da sé anche il nome orgoglioso della tolleranza, è egli stesso illuminato e merita dal mondo e dalla posterità riconoscenti di esser lodato come colui che per primo emancipò il genere umano dalla minorità, almeno da parte del governo e lasciò libero ognuno di valersi della sua propria ragione in tutto ciò che è affare di coscienza. Sotto di lui venerandi ecclesiastici, senza pregiudizio del loro dovere d’ufficio, possono liberamente e pubblicamente, in qualità di studiosi, sottoporre all’esame del mondo i loro giudizi e le loro vedute che qua e là deviano dal credo tradizionale; e tanto più può farlo chiunque non è limitato da un dovere d’ufficio. Questo spirito di libertà si estende anche verso l’esterno, perfino là dove esso deve lottare contro ostacoli esteriori suscitati da un governo che fraintende se stesso. Il governo infatti ha comunque davanti agli occhi uno splendente esempio il quale mostra che nulla la pace pubblica e la concordia della comunità hanno da temere dalla libertà.

Federico II di Hohenzollern (1712 – 1786)
Gli uomini si adoprano da sé per uscire a poco a poco dalla barbarie, purché non si ricorra ad artificiosi strumenti per mantenerli in essa. Ho posto particolarmente nelle cose di religione il punto culminante del rischiaramento, cioè dell’uscita degli uomini da uno stato di minorità il quale è da imputare a loro stessi; riguardo alle arti e alle scienze, infatti, i nostri reggitori non hanno alcun interesse a esercitare la tutela sopra i loro sudditi. Inoltre la minorità in cose di religione è fra tutte le forme di minorità la più dannosa ed anche la più umiliante. Ma il modo di pensare di un sovrano che favorisce quel tipo di rischiaramento va ancora oltre, poiché egli vede che perfino nei riguardi della legislazione da lui statuita non si corre pericolo a permettere ai sudditi di fare uso pubblico della loro ragione e di esporre pubblicamente al mondo le loro idee sopra un migliore assetto della legislazione stessa perfino criticando apertamente quella esistente. Abbiamo in ciò uno splendido esempio, e anche in ciò nessun monarca ha superato quello che noi veneriamo. Ma è pur vero che solo chi, illuminato egli stesso, non ha paura delle ombre e contemporaneamente dispone a garanzia della pubblica pace di un esercito numeroso e ben disciplinato, può enunciare ciò che invece una repubblica non può arrischiarsi di dire: ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete; solamente obbedite!
Si rivela qui uno strano inatteso corso delle cose umane; come del resto anche in altri casi, a considerare questo corso in grande, quasi tutto in esso appare paradossale. Un maggiore grado di libertà civile sembra favorevole alla libertà dello spirito del popolo, epperò pone ad essa limiti invalicabili; un grado minore di libertà civile, al contrario, offre allo spirito lo spazio per svilupparsi con tutte e sue forze. Se dunque la natura ha sviluppato sotto questo duro involucro il germe di cui essa prende la più tenera cura, cioè la tendenza e vocazione al libero pensiero, questa tendenza e vocazione gradualmente reagisce sul modo di sentire del popolo (per cui questo, a poco a poco, diventa sempre più capace della libertà di agire), e alla fin fine addirittura sui principi del governo il quale trova che è nel proprio vantaggio trattare l’uomo, che ormai è più che una macchina, in modo conforme alla di lui dignità.
Esercitazioni
Esercitazione sui primi Scritti precritici (seconda videolezione)
Kahoot test1 (conoscenze di base)= 697188
Kahoot test2 (lessico)= 913456
Esercitazione sulla Critica della ragion pura
1. Sintetizza la critica di Kant al razionalismo di Wolff.
2. «Hume partì principalmente da un unico ma importante concetto della metafisica, cioè quello della connessione di causa ed effetto […] ed invitò la ragione, che in metafisica asserisce di aver generato quel concetto dal suo seno, a rendergli conto con qual diritto essa pensa che qualche cosa possa essere così costituita, che, se essa è posta, perciò anche qualche altra cosa debbe necessariamente esser posta; giacché ciò dice il concetto di causa […]. La questione non era se il concetto di causa sia legittimo, adoperabile e indispensabile riguardo ad ogni conoscenza della natura, perché Hume non lo aveva mai posto in dubbio, ma se esso sia pensato a priori dalla ragione, e in tal modo abbia una verità intrinseca indipendente da ogni esperienza; a questo Hume aspettava una risposta. […] Lo confesso francamente: l’avvertimento di David Hume fu proprio quello che, molti anni or sono, mi risvegliò dal sonno dogmatico e dette un tutt’altro indirizzo alle mie ricerche nel campo della filosofia speculativa». Spiega qual è la soluzione a cui perviene Kant per evitare l’esito scettico a cui era giunto l’empirismo humeano.
3. Kant sostiene che è necessario che la ragione si rivolga a se stessa e «istituisca un tribunale che la garantisca nelle sue giuste pretese». Come chiama questo tribunale e a quali esiti giunge?
4. A cosa si riferisce Kant quando parla della necessità di una rivoluzione copernicana nella teoria della conoscenza?
5. Spiega il significato dei concetti di “critica” e “trascendentale”.
6. Illustra le caratteristiche del giudizio analitico e del giudizio sintetico, spiegando quali sono i limiti del loro utilizzo in campo scientifico.
7. Quali caratteristiche deve avere, invece, il giudizio scientifico? Perché?
8. Indica il campo di indagine dell’estetica trascendentale, definendo i concetti di spazio, tempo ed intuizione.
9. Spiega in cosa le categorie kantiane si differenziano essenzialmente da quelle aristoteliche.
10. Illustra l’attività dell’intelletto e dell’Io penso.
11. Spiega perché per Kant la conoscenza umana sia tutta fenomenica e perché, ciononostante, sia possibile una conoscenza vera, come attestato dalla matematica e dalla fisica.
12. Spiega cos’è la ragione nella Critica della ragion pura e perché la sua attività sia per Kant una “logica della parvenza”, indicando poi una delle critiche che il filosofo muove alle pretese della metafisica dogmatica.
Esercitazione sulla Risposta alla domanda Che cos’è l’Illuminismo
Nella Risposta alla domanda Che cos’è l’Illuminismo, Kant oppone la minorità e l’eterodirezione al sapere e all’autonomia. In classe è stato proposto un confronto tra questa prospettiva e quella socratica. Rileggi lo stralcio seguente della lezione sul filosofo ateniese, poi rispondi alla domanda sottostante:
Socrate, scrive Senofonte,
era sempre in mezzo alla gente. La mattina si trovava nei passeggi e nei ginnasi, nell’ora di maggior frequenza si poteva vederlo sulla piazza. Il resto del giorno lo passava in quei luoghi dove sperava di trovarsi in compagnia più numerosa. Solitamente era lui che parlava e chiunque poteva ascoltarlo. Ragionava sempre delle cose umane, considerando che cosa (ti estì) sia la pietà, che cosa empietà, che cosa onesto, che cosa disonesto, che cosa giusto, che cosa ingiusto, che cosa saggezza e pazzia, fortezza e viltà, che cosa sia stato, governo, uomo di stato, che cosa arte di governo e altre cose simili, dalla cui conoscenza o ignoranza dipendeva, a suo parere, l’essere uomini valorosi e onesti, oppure degni d’essere detti anime di schiavi [si noti qui, che agli occhi di un greco, gli schiavi non erano creature inferiori per natura, ma soggetti dipendenti, privi di libertà, da governare come cose]. [Senofonte, Detti e fatti memorabili di Socrate, I, 1].
Come mostra questo testo, Socrate riteneva che fosse impossibile mantenere la propria libertà di cittadini, cioè la capacità di autogovernarsi senza una profonda conoscenza delle cose.
Questione e caso concreto:
Socrate riteneva che non bastasse esprimere un’opinione (o “fare di testa propria” come si diceva stamattina in classe) per essere liberi. Libero è infatti non chi esprime un’opinione credendola propria, ma chi agisce in modo razionale (obbedendo al “dovere”, kantianamente inteso), quindi giusto. Esaminiamo un caso concreto: nella nostra scuola è fatto divieto agli studenti di usare l’ascensore perché riservato agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Si tratta di una norma spesso disattesa. Perché alcuni studenti la violano? Con quale ragione? Si tratta di un comportamento autonomo, cioè libero, in senso socratico-kantiano, o no?





















Commenti recenti