La teoria della conoscenza e la filosofia politica del fondatore del pensiero liberale.
Indice
1. Il problema della conoscenza tra 600 e 700
1.1 Il razionalismo
1.2 L’empirismo e la critica dell’innatismo
1.3 Il problema della conoscenza per Locke
1.4 La critica all’innatismo e la teoria delle idee
1.5 La critica della metafisica e dell’idea di sostanza
1.6 L’analisi del linguaggio e la concezione della conoscenza
2. Il pensiero politico
2.1 I Due Trattati sul governo civile: lo stato di natura e la fondazione della proprietà privata
2.1.1 L’importanza del pensiero politico lockeano
2.1.2 I due Trattati sul governo
2.1.3 La confutazione delle tesi di Filmer
2.1.4 Lo stato di natura e la fondazione del diritto di proprietà
2.1.5 La spinta naturale all’autoconservazione
2.1.6 La derivazione della proprietà dal lavoro
2.1.7 Le due fasi dello stato di natura e la legittimazione del possesso privato
2.2 Locke teorico dello stato liberale
2.2.1 Socievolezza e insocievolezza secondo Locke
2.2.2 La divisione dei poteri dello Stato
2.2.3 I poteri illegittimi e il diritto alla rivoluzione
1. Il problema della conoscenza tra 600 e 700
Niente è nell’intelletto che non fu già nei sensi.
Tommaso d’Aquino
Il problema del valore della conoscenza, cioè della corrispondenza delle nostre rappresentazioni con la realtà esterna, è il problema specifico della filosofia moderna da Cartesio a Kant.
Tra il seicento e il settecento la questione decisiva diventa la determinazione di quanto, nel processo conoscitivo, derivi dall’esperienza e quanto dall’attività dell’intelletto.
Razionalismo ed empirismo possono essere considerate, al riguardo, le due grandi modalità attraverso cui la filosofia tenta di risolvere la discussione circa l’origine, i limiti e la validità della conoscenza.




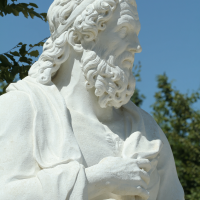










Commenti recenti