Un articolo – scritto nel 2012 per Oreundici – sul disagio giovanile contemporaneo e l’incapacità degli adolescenti di operare il passaggio dalla libido narcistica alla libido oggettuale, dall’immediatezza delle pulsioni più elementari all’eros, quale effetto della crisi storica di fondamento che attraversa la nostra civiltà.
 Un filosofo e psicoanalista argentino Miguel Benasayag, che vive da molti anni a Parigi, le cui opere sono in parte tradotte anche in italiano, e un professore di psichiatria infantile e dell’ adolescenza Gérard Schmit che insegna all’ università di Reims, hanno posto sotto osservazione i servizi di consulenza psicologica e psichiatrica diffusi in Francia e si sono accorti che a frequentarli, per la gran parte, sono persone le cui sofferenze non hanno una vera e propria origine psicol
Un filosofo e psicoanalista argentino Miguel Benasayag, che vive da molti anni a Parigi, le cui opere sono in parte tradotte anche in italiano, e un professore di psichiatria infantile e dell’ adolescenza Gérard Schmit che insegna all’ università di Reims, hanno posto sotto osservazione i servizi di consulenza psicologica e psichiatrica diffusi in Francia e si sono accorti che a frequentarli, per la gran parte, sono persone le cui sofferenze non hanno una vera e propria origine psicol ogica, ma riflettono la tristezza diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento permanente di insicurezza e di precarietà. Quali «tecnici della sofferenza» si sono sentiti impreparati ad affrontare problemi che non fossero di natura psicopatologica. E invece di adagiarsi tranquillamente sui farmaci a loro disposizione per curare il disordine molecolare e così stabilizzare la crisi, si sono messi a studiare e a pensare il senso che si nasconde nel cuore del sintomo, quando la crisi non è tanto del singolo, quanto il riflesso nel singolo della crisi della società. Ne è nato un libro bellissimo, la cui lettura consiglierei a tutti i giovani e a tutti quelli che ne hanno cura. Il titolo è L’ epoca delle passioni tristi (Feltrinelli) [le prime venti pagine sfogliabili qui].
ogica, ma riflettono la tristezza diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento permanente di insicurezza e di precarietà. Quali «tecnici della sofferenza» si sono sentiti impreparati ad affrontare problemi che non fossero di natura psicopatologica. E invece di adagiarsi tranquillamente sui farmaci a loro disposizione per curare il disordine molecolare e così stabilizzare la crisi, si sono messi a studiare e a pensare il senso che si nasconde nel cuore del sintomo, quando la crisi non è tanto del singolo, quanto il riflesso nel singolo della crisi della società. Ne è nato un libro bellissimo, la cui lettura consiglierei a tutti i giovani e a tutti quelli che ne hanno cura. Il titolo è L’ epoca delle passioni tristi (Feltrinelli) [le prime venti pagine sfogliabili qui].
Si tratta di passioni che lasciano le famiglie disarmate e angosciate all’ idea di non essere in grado di provvedere al problema che affligge uno dei loro componenti, quindi di non essere una «buona famiglia», quando invece le passioni tristi hanno la loro origine nella crisi della società che, senza preavviso, fa il suo ingresso nei centri di consulenza psicologica e psichiatrica, lasciando gli operatori disarmati. In che consiste questa crisi? Da un cambiamento di segno del futuro: dal «futuro-promessa» al «futuro-minaccia». E siccome la psiche è sana quando è aperta al futuro (a differenza della psiche depressa tutta raccolta nel passato, e della psiche maniacale tutta concentrata sul presente) quando il futuro chiude le sue porte o, se le apre, è solo per offrirsi come incertezza, precarietà, insicurezza, inquietudine, allora «il terribile è già accaduto», perché le iniziative si spengono, le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode.
 Per i due psichiatri francesi, e io concordo con loro, tutto ciò è incominciato con la morte di Dio che ha segnato la fine dell’ ottimismo teologico, che visualizzava il passato come male, il presente come redenzione, il futuro come salvezza. La morte di Dio non ha lasciato solo orfani, ma anche eredi. La scienza, l’utopia e la rivoluzione hanno proseguito, in forma laicizzata, questa visione ottimistica della storia, dove la triade: colpa, redenzione, salvezza trovava la sua riformulazione in quell’omologa prospettiva dove il passato appare come male, la scienza o la rivoluzione come redenzione, il progresso (scientifico o sociologico) come salvezza. Il positivismo di fine Ottocento era infatti animato da una sorta di messianesimo scientifico, che assicurava un domani luminoso e felice grazie ai progressi della scienza. Sul versante sociologico Marx evidenziava le contraddizioni del capitalismo
Per i due psichiatri francesi, e io concordo con loro, tutto ciò è incominciato con la morte di Dio che ha segnato la fine dell’ ottimismo teologico, che visualizzava il passato come male, il presente come redenzione, il futuro come salvezza. La morte di Dio non ha lasciato solo orfani, ma anche eredi. La scienza, l’utopia e la rivoluzione hanno proseguito, in forma laicizzata, questa visione ottimistica della storia, dove la triade: colpa, redenzione, salvezza trovava la sua riformulazione in quell’omologa prospettiva dove il passato appare come male, la scienza o la rivoluzione come redenzione, il progresso (scientifico o sociologico) come salvezza. Il positivismo di fine Ottocento era infatti animato da una sorta di messianesimo scientifico, che assicurava un domani luminoso e felice grazie ai progressi della scienza. Sul versante sociologico Marx evidenziava le contraddizioni del capitalismo  in vista di una radicale trasformazione del mondo, sul versante psicologico Freud ipotizzava un prosciugamento delle forze inconsce non controllate dall’ Io, perché
in vista di una radicale trasformazione del mondo, sul versante psicologico Freud ipotizzava un prosciugamento delle forze inconsce non controllate dall’ Io, perché
dov’ era l’ Es deve subentrare l’Io. Questa è l’ opera della civiltà.
L’Occidente, abbandonato il pessimismo degli antichi greci che, a sentire Nietzsche:
Sono stati gli unici ad avere la forza di guardare in faccia il dolore,
si è consegnato senza riserve all’ottimismo della tradizione giudaico-cristiana che, sia nella versione religiosa, sia nelle forme laicizzate della scienza, dell’ utopia e della rivoluzione, ha guardato l’ avvenire sorretta dalla convinzione che la storia dell’ umanità è inevitabil mente una storia di progresso e quindi di salvezza.
mente una storia di progresso e quindi di salvezza.
Oggi questa visione ottimistica è crollata. Dio è davvero morto e i suoi eredi (scienza, utopia e rivoluzione) hanno mancato la promessa. Inquinamenti di ogni tipo, disuguaglianze sociali, disastri economici, comparsa di nuove malattie, esplosioni di violenza, forme di intolleranza, radicamento di egoismi, pratica abituale della guerra hanno fatto precipitare il futuro dall’estrema positività della tradizione giudaico-cristiana all’ estrema negatività di un tempo affidato alla casualità senza direzione e orientamento. Il futuro da «promessa» è diventato «minaccia». E questo perché se è vero che la tecnoscienza progredisce nella conoscenza del reale, contemporaneamente ci getta in una forma di ignoranza molto diversa, ma forse più temibile, che è poi quella che ci rende incapaci di far fronte alla nostra infelicità e ai problemi che ci inquietano.
Per dirla con Spinoza, viviamo in u n’ epoca dominata da quelle che il filosofo chiamava le «passioni tristi», dove il riferimento non era al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla disgregazione e alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre a cui l’ Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà. Certo nessuno si reca a un consultorio psicologico per un adolescente esordendo: «Buongiorno dottore, soffro molto a causa della crisi storica che stiamo attraversando». In compenso i consultori sono quotidianamente sollecitati da genitori e insegnanti che non sanno più come far fronte all’ indolenza dei loro figli o dei loro alunni, ai processi di demotivazione che li isola nelle loro stanze a stordirsi le orecchie di musica, all’escalation della violenza, allo stordimento degli spinelli che intercalano ore di ignavia. Come sono riconducibili tutti questi sintomi alla «crisi storica»? La mancanza di un futuro come promessa arresta il desiderio nell’ assoluto presente. Meglio star bene e gratificarsi oggi se il domani è senza prospettiva. Ciò significa che nell’adolescente non si verifica più quel passaggio naturale dalla libido narcisistica (che investe sull’ amore di sé) alla libido oggettuale (che investe sugli altri e sul mondo). In mancanza di questo passaggio, bisogna spingere gli adolescenti a studiare con motivazioni utilitaristiche, impostando un’ educazione finalizzata alla sopravvivenza, dove è implicito che «ci si salva da soli», con conseguente affievolimento dei legami emotivi, sentimentali e sociali.
n’ epoca dominata da quelle che il filosofo chiamava le «passioni tristi», dove il riferimento non era al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla disgregazione e alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre a cui l’ Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà. Certo nessuno si reca a un consultorio psicologico per un adolescente esordendo: «Buongiorno dottore, soffro molto a causa della crisi storica che stiamo attraversando». In compenso i consultori sono quotidianamente sollecitati da genitori e insegnanti che non sanno più come far fronte all’ indolenza dei loro figli o dei loro alunni, ai processi di demotivazione che li isola nelle loro stanze a stordirsi le orecchie di musica, all’escalation della violenza, allo stordimento degli spinelli che intercalano ore di ignavia. Come sono riconducibili tutti questi sintomi alla «crisi storica»? La mancanza di un futuro come promessa arresta il desiderio nell’ assoluto presente. Meglio star bene e gratificarsi oggi se il domani è senza prospettiva. Ciò significa che nell’adolescente non si verifica più quel passaggio naturale dalla libido narcisistica (che investe sull’ amore di sé) alla libido oggettuale (che investe sugli altri e sul mondo). In mancanza di questo passaggio, bisogna spingere gli adolescenti a studiare con motivazioni utilitaristiche, impostando un’ educazione finalizzata alla sopravvivenza, dove è implicito che «ci si salva da soli», con conseguente affievolimento dei legami emotivi, sentimentali e sociali.
La mancanza di un futuro come promessa non conferisce ai genitori e agli insegnanti l’autorità di indicare la strada. Tra adolescenti e adulti subentra allora un rapporto «contrattualistico» dove genitori e insegnanti si sentono continuamente tenuti a giustificare le loro scelte nei confronti del giovane, che accetta o meno ciò che gli viene proposto in un rapporto ugualitario. Ma la relazione tra giovani e adulti non è simmetrica, e trattare l’ adolescente come un proprio pari significa non contenerlo, e soprattutto lasciarlo solo di fronte alle proprie pulsioni e all’ansia che ne deriva. Quando i sintomi di disagio si fanno evidenti l’atteggiamento dei genitori e degli insegnanti oscilla tra la coercizione dura (che può avere senso quando le promesse del futuro sono garantite) e la seduzione di tipo commerciale di cui la cultura berlusconiana che si va diffondendo è un esempio. Senonché anche i giovani di oggi devono fare il loro Edipo, devono cioè esplorare la loro potenza, sperimentare i limiti della società, affrontare tutte le funzioni tipiche dei riti di passaggio dell’ adolescenza, tra cui uccidere simbolicamente l’autorità, il padre. E siccome questo processo non può avvenire in famiglia dove, per effetto dei rapporti contrattuali tra padri e figli, l’autorità non esiste più, i giovani finiscono col fare il loro Edipo al di fuori, scatenando nel quartiere, nello stadio, nella città, nella società la violenza contenuta in famiglia.
Sono, questi, due esempi dei molti che gli autori del libro illustrano per mostrare il nesso tra il passaggio storico del futuro come promessa al futuro come minaccia e le manifestazioni psico (pato) logiche del disagio dei giovani che non riescono più a percepire l’integrazione sociale, l’acquisizione dell’ apprendimento, l’ investimento nei progetti, come qualcosa di connesso a un loro desiderio profondo, che è poi il desiderio di desiderare la vita. A ciò si aggiunga che le passioni tristi e il fatalismo non mancano di un certo fascino, ed è facile farsi sedurre dal canto delle sirene della disperazione, assaporare l’ attesa del peggio, lasciarsi avvolgere dalla notte apocalittica che, dalla minaccia nucleare a quella terroristica, cade come un cielo buio su tutti noi. Ma è anche vero che le passioni tristi sono una costruzione, un modo di interpretare la realtà, non la realtà stessa, che ancora serba delle risorse se solo non ci facciamo irretire da quel significante oggi dominante che è l’ insicurezza. Certo la nostra epoca smaschera l’ illusione della modernità che ha fatto credere all’ uomo di poter cambiare tutto secondo il suo volere.
Non è così. Ma l’ insicurezza che ne deriva non deve portare la nostra società ad aderire massicciamente a un discorso di tipo paranoico, in cui non si parla d’altro se non della necessità di proteggersi e sopravvivere, perché allora si arriva al punto che la società si sente libera dai principi e dai divieti, e allora la barbarie è alle porte. Se l’estirpazione radicale dell’insicurezza appartiene ancora all’utopia modernista dell’onnipotenza umana, la strada da seguire è un’altra, e precisamente quella della costruzione dei legami affettivi e di solidarietà, capaci di spingere le persone fuori dall’isolamento nel quale la società tende a rinchiuderle, in nome degli ideali individualistici che, a partire dall’America, si vanno paurosamente diffondendo anche da noi.








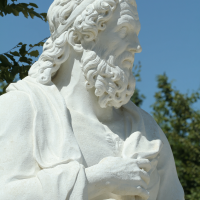


Commenti recenti