« Non presumere mai cattiveria laddove basti la stupidità »
Robert J. Hanlon
La sua definizione di stupido («colui che causa danno agli altri senza trarne vantaggi per se stesso») è ormai un classico, nella grande tradizione che va almeno da Flaubert (Bouvard et Pécuchet) a Fruttero & Lucentini (La prevalenza del cretino).
Di questo saggio uscito in Inghilterra 23 anni fa, è ora disponibile un’edizione italiana. Il Mulino pubblica infatti (su carta e in formato e-book) The Basic Law of Human Stupidity, di Carlo M. Cipolla, parte di quello che fu il fortunatissimo Allegro ma non troppo, pubblicato nel 1988 e da allora bestseller assoluto dell’editrice bolognese. Era nato nel ’76 come regalo, cento copie numerate che il grande storico dell’economia mandò agli amici di Berkeley, dove insegnava. Tratto da LaStampa.
Dai presocratici …
Quello di Cipolla, insomma, è un libro sulla stupidità intesa come forma suprema di comportamento antisociale. E’ interessante però sostare un attimo sulla definizione dell’autore che, forse perché insegnava (economia) in Inghilterra (e non dev’essere un caso che uno che ha passato la vita a studiare le logiche del mercato sia fatto una cultura sulla stupidità), non poteva fare a meno di pensare in termini utilitaristici: se lo stupido è chi danneggia gli altri senza trarre vantaggio per se stesso, il non stupido – o furbo – è chi danneggiando gli altri consegue almeno un vantaggio per sé. Se ciò che intende Cipolla si limita a questo, mi piacerebbe sapere quale giudizio si deve dare su chi cercando un vantaggio individuale danneggia “gli altri” in quanto nome collettivo che comprende lui stesso. Come considerare, ad esempio, la recente morte per cancro di Vincenzo Schiavone, camorrista casalese che aveva speso la propria vita nel traffico di rifiuti tossici, affondandoli nello specchio di mare giusto davanti casa e spingendosi persino a ospitarli temporaneamente nella propria cantina?
 Avrei una risposta che trae spunto però da qualcosa di molto più remoto dell’opera di Flaubert e Lucentini e che inizia almeno con Eraclito (o Anassimandro): stupido è chi non vede dove inizia e finisce la propria esistenza, pensando (erroneamente) di poterla circoscrivere all’orticello di casa. E’ questo errore capitale a fare delle società disperate in cui viviamo e di noi stessi degli stupidi per eccellenza, “gente senza testa, che non sa decidersi” (Parmenide), a cui Eraclito ricordava che “non ascoltando me, ma il Lógos è saggio convenire che tutto è uno”. Se Schiavone (morto a 37 anni dimostrandone il doppio) avesse dato retta ai presocratici forse godrebbe ancora del suo orto.
Avrei una risposta che trae spunto però da qualcosa di molto più remoto dell’opera di Flaubert e Lucentini e che inizia almeno con Eraclito (o Anassimandro): stupido è chi non vede dove inizia e finisce la propria esistenza, pensando (erroneamente) di poterla circoscrivere all’orticello di casa. E’ questo errore capitale a fare delle società disperate in cui viviamo e di noi stessi degli stupidi per eccellenza, “gente senza testa, che non sa decidersi” (Parmenide), a cui Eraclito ricordava che “non ascoltando me, ma il Lógos è saggio convenire che tutto è uno”. Se Schiavone (morto a 37 anni dimostrandone il doppio) avesse dato retta ai presocratici forse godrebbe ancora del suo orto.
.. a Stiegler
Per capire perché le società in cui viviamo sono un esempio perfetto di stupidità, può essere utile leggersi l’ultima intervista di Bernard Stigler, nella quale il filosofo invita il mondo a battersi contro la bêtise (bêtise, infatti, significa stupidità, castroneria, bestialità). Giocando con il titolo della celebre L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin, il sito Kainòs che ha raccolto l’intervista l’ha titolata:
L’ignoranza nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
Il punto di maggiore interesse di questa lunga intervista è il terzo.
Bernard Stiegler, professore al Goldsmiths College di Londra, all’Université de Technologie di Compiègne e visiting professor alla Cambridge University, nonché Direttore dell’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Georges Pompidou di Parigi, è sicuramente uno dei filosofi più attenti alle trasformazioni della società contemporanea, come dimostrano i suoi numerosi libri pubblicati negli ultimi anni. A dispetto di alcuni titoli ”apocalittici” delle sue pubblicazioni – come La misère symbolique o Mécréance et miscrédit – e delle analisi fortemente critiche per le quali è conosciuto anche in Italia (sebbene ancora poco tradotto), Stiegler si distingue sicuramente per la serena volontà di trasformazione sociale, economica, politica e culturale dello stato attuale delle cose, prendendo come bersaglio critico l’ignoranza in quanto fenomeno socialmente prodotto dall’ideologia e dalle tecnologie del consumo. Da questa volontà, condivisa con altri pensatori e studiosi, nasce il progetto di Ars Industrialis, l’associazione di cui Stiegler è presidente e uno dei fondatori. In particolare, l’ambizione di Ars Industrialis, è quella di essere “un’associazione internazionale per l’ecologia industriale dello spirito”, che sappia coniugare critica teorica e proposta programmatica su tutti i piani del sapere, a incominciare dalle scienze umane.
Stiegler ha inoltre pubblicato, qualche anno fa, un libro intitolato La télécratie contre la démocratie, offrendoci così un buon movente per accogliere le sue parole, attraverso un’intervista, in questo numero di Kainos.
1) Nel 2006 lei ha pubblicato La télécratie contre la démocratie, un libro che è ancora molto attuale rispetto alla situazione italiana. Se è lecito pensare che i dibattiti politici in Italia oggi risentano del «regno dell’ignoranza» di cui lei ha parlato, come si può fare per uscirne, al di là di un cambiamento istituzionale del potere?
STIEGLER: Si tratta di un’enorme questione, che mi pongo tutti i giorni. Penso però che vi sia un problema di traduzione, perché ciò che lei chiama il ‘‘regno dell’ignoranza’’, in quel libro è definito principalmente come il ‘‘regno della bêtise’’.
La bêtise non è l’ignoranza e non è neanche, propriamente, la stessa cosa della stupidità. Credo che oggi ci troviamo in una situazione che, in un altro libro, ho definito di ‘‘bêtise sistemica’’, ossia all’interno di un sistema che si è instaurato e ha sottomesso chiunque, in una maniera o nell’altra, alla propria bêtise. Quando affermo che è un sistema, non voglio dire che delle persone abbiano elaborato deliberatamente e coscientemente tale sistema. Voglio dire che si tratta di qualcosa che si è sviluppato sistematicamente, nel senso della teoria dei sistemi. Il processo sistemico è indotto dai vincoli interni al sistema. Preciso questo aspetto perché per me è molto importante. In quello che nella domanda è stato introdotto come il regno dell’ignoranza, che io definirei piuttosto il regno della bêtise, si ha la combinazione di due cose: da una parte un fenomeno di proletarizzazione, ossia di distruzione ed espropriazione dei saperi, e dall’altra parte un fenomeno di pulsionalizzazione, vale a dire di sfruttamento e di captazione delle pulsioni.
Noi, gli i taliani e i francesi, i due più grandi paesi latini d’Europa, conosciamo bene questo problema perché abbiamo dei dirigenti politici che sono degli esseri pulsionali. Berlusconi e Sarkozy condividono in modo evidente un carattere pulsionale che, per esempio, non osserviamo chiaramente in Obama o in Angela Merkel. Ciò non significa che questi ultimi non abbiano delle pulsioni, tutti hanno delle pulsioni, ma loro le controllano meglio.
taliani e i francesi, i due più grandi paesi latini d’Europa, conosciamo bene questo problema perché abbiamo dei dirigenti politici che sono degli esseri pulsionali. Berlusconi e Sarkozy condividono in modo evidente un carattere pulsionale che, per esempio, non osserviamo chiaramente in Obama o in Angela Merkel. Ciò non significa che questi ultimi non abbiano delle pulsioni, tutti hanno delle pulsioni, ma loro le controllano meglio.
È chiaro invece che in Italia e in Francia abbiamo il problema di avere dei dirigenti che assolutamente non controllano le pulsioni. Vi è in questo una ragione molto precisa; infatti si sono fatti eleggere grazie alle loro pulsioni, ossia attraverso una identificazione mimetica al loro comportamento pulsionale. Tra l’altro, nel libro che ha citato, La télécratie contre la démocratie, io mi opponevo sia a Sarkozy che a Ségolène Royale, che è stata la candidata del Partito Socialista ma che per me è tanto pulsionale quanto Sarkozy e quindi l’ho percepita tanto pericolosa quanto lui (d’altronde sono molto contento perché ci sono state le primarie socialiste in Francia e lei è arrivata quasi ultima: ciò vuol dire che la storia l’ha cestinata, e me ne rallegro).
Comunque, se questi candidati hanno potuto essere eletti è perché si sono appoggiati molto ai media, in particolare alla televisione, i quali sono diventati essi stessi pulsionali. E se questi media sono diventati pulsionali è perché da decenni, da quasi 70 anni, le industrie culturali sfruttano il desiderio umano. Il problema è che questo sfruttamento del desiderio ha condotto alla sua distruzione, ossia alla sostituzione del desiderio con la pulsione: oggi le persone hanno sempre meno desiderio e sempre più pulsioni.
Il desiderio non è la pulsione, bensì una trasformazione della pulsione. Dico questo per precisare ciò che chiamo ‘‘il regno della bêtise’’ e che nella domanda viene posto come ‘‘regno dell’ignoranza’’. Sfortunatamente, la bêtise è molto più grave dell’ignoranza: conosco tante persone molto ignoranti, come mio figlio di cinque anni che ignora molte cose, e da un certo punto di vista è una chance. L’ignoranza può essere una forza. Il problema non è l’ignoranza, ma la bêtise. Per contro, l’adulto non deve essere ignorante. L’adulto ignorante è evidentemente colui che è impotente, incompetente e che non ha alcun sapere. In tal senso, ciò che lei chiama “l’ignoranza” corrisponde anche a ciò che definisco come proletarizzazione.
Esiste una combinazione tra la bêtise come sfruttamento delle pulsioni e la proletarizzazione in quanto costruzione di un’ignoranza che rende le persone delle ‘‘bestie’’ in un duplice senso. Sono bestie perché non hanno cultura e perché hanno perduto tutti i loro saperi. Non si tratta soltanto dei saperi astratti, che si apprendono a scuola e all’università, ma anche del saper vivere, del saper educare i propri figli, dei saperi elementari che è necessario conoscere per essere un essere umano e non una bestia. Per esempio, Berlusconi ha perduto questi saperi, e lui stesso è una vittima – non soltanto la gente che è governata da lui. In generale, i membri della classe dirigente hanno perduto i propri saperi.
Questo si combina con la bêtise pulsionale, ossia con dei fenomeni di regressione. La società della bêtise è una società assolutamente regressiva, e ciò che si può osservare in Italia da molto tempo, e in Francia dagli anni Cinquanta, è un fenomeno di enorme regressione, con conseguenze di regressione sociale, per esempio nei termini di diritto del lavoro. Questo processo di regressione fa dire a molte persone, oggi in Francia, che sembra di essere ritornati all’epoca del capitalismo del 1870, ossia a un capitalismo assolutamente barbaro.
Allora, la questione che mi ha posto è ‘‘Cosa bisogna fare per uscire da questa situazione?’’. Penso che, per uscire da tale situazione, purtroppo, sia necessario fare l’esperienza dell’affondamento. L’Italia è stata svalutata dalle agenzie di rating, penso che la Francia lo sarà presto, l’Europa sta per affossarsi sul piano economico, per una ragione molto precisa. Per me c’è una ragione per la quale il capitalismo mondiale è in procinto di affossarsi, ivi compresa la Cina (perché anche la Cina comincia ad avere dei  problemi).
problemi).
La ragione è data dal fatto che la bêtise sistemica, che è una regressione pulsionale, conduce al disinvestimento, e io utilizzo la parola disinvestimento nel senso psicanalitico come in quello economico. In psicanalisi, a partire da Freud, l’investimento è un concetto molto importante. Ciò che Freud descrive come l’oggetto del desiderio, l’oggetto della libido, è l’oggetto di un investimento. Investimento vuol dire fidelizzazione, fedeltà, attaccamento.
Ora, oggi viviamo in una società che è fondata sull’infedeltà, sul disimpegno, sulla ‘‘gettabilità’’. Significa che si gettano le imprese come si gettano i rifiuti, le confezioni di plastica, le scatole, le bottiglie di Coca Cola, e si gettano anche i bambini – perché ci sono persone che gettano i loro figli. Si sono distrutti tutti i dispositivi di attaccamento, e quindi si produce un processo di disinvestimento. Questo processo di disinvestimento è prodotto dalla bêtise sistemica di cui la televisione è un organo principale, ma sfortunatamente non è l’unico. Per poter uscire da questa situazione esiste una possibilità: essa risiede in parte nel fatto che la situazione arrivi a un punto di contraddizione tale che essa divenga evidente – si tratta di una tematica marxiana.

Karl Marx
Marx diceva che il capitalismo si sarebbe trasformato necessariamente, perché avrebbe trovato delle contraddizioni, e noi siamo nel momento in cui una contraddizione del genere viene vissuta. Sappiamo che c’è stata una contraddizione come questa tra il 1880 e il 1890, ed essa ha portato alla prima guerra mondiale.
La questione per noi è allora comprendere che ci stiamo dirigendo verso la terza guerra mondiale, e siamo consapevoli che ciò non è sostenibile, non possiamo giungere alla terza guerra mondiale. È assolutamente indicibile perché significherebbe la distruzione del pianeta. D’altronde, non possiamo essere sicuri di non arrivarci: può svilupparsi una bêtise tale da farci ritrovare nel mezzo di una terza guerra mondiale, che sarebbe sicuramente l’ultima guerra e l’ultimo evento del pianeta.
Questo è assolutamente possibile, può succedere domani, può essere un processo assai veloce. Ma oggi molte persone incominciano a rendersene conto. Personalmente, incontro qualsiasi tipo di persone nel mondo politico (compreso politici di destra), nel mondo economico, nelle banche, nelle imprese e sono tutti smarriti, presi dal panico, sul punto di dirsi che questa volta sarà davvero una catastrofe. E quindi è giunto il momento di fare delle proposte. La sola possibilità che abbiamo per uscire da questa situazione è formulare delle proposte positive, ossia inventare. Le offro un esempio molto concreto.
Non molto tempo fa ho incontrato il direttore di una grande rete televisiva francese. Gli ho detto:
la televisione è finita. In ogni caso, la televisione come lei l’ha conosciuta, come io l’ho conosciuta (sulla quale ho lavorato, per esempio, all’INA) è stata una televisione finanziata per il 90-95% dalla pubblicità. Oggi la pubblicità si muove su Internet.
Ora, c’è ancora una buona fetta di pubblicità che viene trasmessa dalla televisione, ma questo non può durare a lungo, Google sta per ospitare 20 canali televisivi su Internet e la pubblicità finirà sul web. Questo significa che per la seconda volta TF1 (l’equivalente di Fininvest in Italia) avrà perduto dei soldi quest’anno. TF1 non guadagna più come prima perché il flusso pubblicitario si sta riducendo sempre più. Penso che la televisione dovrà sviluppare una nuova utilità sociale, e in questo modo potrà diventare qualcosa di interessante. Vede, ad esempio, io e lei stiamo facendo della televisione [l’intervista è avvenuta in videoconferenza su Skype].
Si tratta di televisione ‘‘punto a punto’’, da una persona all’altra; la videoconferenza è un tipo di televisione. E, d’altronde, Ars Industrialis diffonde 150 filmati televisivi che sono in accesso sul server e sono visionati parecchio. Inoltre, oggi si potrebbe immaginare – ed è così che mi accingo a rispondere precisamente alla vostra domanda – che gli storici, gli antropologi, i geografi, ma chiunque, anche i fisici, utilizzino la televisione per produrre dei lavori universitari, per fare delle tesi. Penso, ad esempio, a Jean Roche, che è molto conosciuto in Francia come cineasta, ma è anche un antropologo e ha fatto degli straordinari film di antropologia, studiando la mentalità africana.
Personalmente, quando sono stato direttore dell’INA, ho ricevuto una storica che si chiama Sylvie Lindeperg e che oggi è Professore alla Sorbona. Lei faceva una tesi sul ruolo del cinema nella rappresentazione della Resistenza in Francia; io le ho dato accesso all’archivio dell’INA e l’ho aiutata perché potesse fare la sua tesi con le immagini, in immagini. Questo perché fare una tesi sul cinema pubblicando un libro è la stessa cosa che fare una tesi su Omero o su Proust raccontando una storia come farebbe un Griot africano, ossia praticando il modo di comunicare che avevano le persone prima dell’apparizione della scrittura. Questo è ridicolo. Non si può fare la tesi su di un libro se non scrivendo un libro. Penso perciò che non si possa fare una tesi sul cinema se non facendo un film. Ma il film in questione sarà un film di genere nuovo, sarà un film teorico.
Che cosa ho voluto dire con questo? È che, se si insegna in un liceo lo si conosce bene, è difficile oggi, in Francia, insegnare in un liceo, perché i ragazzi ai quali fate lezione hanno tutti lo smartphone in tasca, o una macchina fotografica, ed è molto difficile riuscire a captare l’attenzione degli alunni nell’insegnamento secondario. Per contro, ho un amico, che è stato un mio allievo, il quale ha istituito un corso di fisica in cui gli alunni creavano delle immagini durante il corso. Questo ha funzionato molto bene.
Penso che oggi, nelle università, non si debba continuare semplicemente a scrivere dei libri, ma si dovrebbero fare dei film, montare dei siti audio o video, dei siti wiki, e si debbano sviluppare degli strumenti di ricerca e delle pubblicazioni che traggano profitto da questi media. Se si facesse in questo modo, i giovani italiani e francesi direbbero: ‘‘è molto stimolante la scuola, si fanno delle cose davvero interessanti’’. Per far ciò, si dovrebbero finanziare delle tesi che sviluppino degli strumenti di ricerca audio e video, digitali, adattati ai bisogni delle persone che fanno ricerca in letteratura, in poesia, in antropologia, in geografia, ecc. Si costituirebbe finalmente un rinnovamento della ‘‘civilizzazione’’.
La stessa civilizzazione che è nata in Grecia con l’appropriazione della scrittura a mano. In seguito, nel XV e nel XVI secolo, essa si è rinnovata attraverso il protestantesimo, perché è il protestantesimo che, attraverso Lutero, appropriandosi della stampa ha completamente stravolto, non soltanto la religione, ma tutto ciò che rientra in quel che si chiama ‘‘l’umanesimo’’, la costruzione dei saperi, la vita delle università, ecc. Oggi dobbiamo fare una terza rivoluzione della scrittura, poiché in effetti il digitale è una forma della scrittura elettronica, e se noi non ricostruiamo un progetto politico, scientifico, artistico, industriale e quindi economico, ma anche ecologico, attorno allo sviluppo di questi saperi, andremo incontro alla catastrofe che si trova dietro l’angolo, ossia la distruzione dell’umanità.
È questa la sfida e se gliene parlo è perché discuto personalmente con quelle aziende televisive a cui ho fatto cenno prima, per cominciare a istituire delle cose come questa, in cui l’idea è che le imprese televisive non devono più essere dei luoghi o delle fabbriche di programmi ma dei luoghi in cui si mettono a disposizione dei mezzi tecnici, delle conoscenze tecniche, delle modalità di diffusione di reti e di finanziamenti, per sostenere laboratori di ricerca o studenti di Master2 [la nostra laurea specialistica], per sviluppare un’autentica attività editoriale accademica o teorica, per lottare contro l’ignoranza, perché alla fine è questo lottare davvero contro l’ignoranza, nel senso in cui ne abbiamo parlato prima.
2) Ars Industrialis, l’associazione di cui lei è uno dei fondatori, ha pubblicato il suo secondo manifesto nel 2010 (il primo era del 2005), dimostrando un’attenzione politica encomiabile di fronte alla crisi planetaria attuale. In particolare, avete lanciato una proposta economica molto ‘‘filosofica’’ per uscire da questa situazione: l’economia della contribuzione, dei software liberi e della partecipazione civica. Inoltre, Ars Industrialis produce cultura – economica, politica, ma soprattutto ‘‘industriale’’ – attraverso seminari, riflessioni, assemblee e conferenze pubbliche, ecc. In altre parole, combattete l’ignoranza al di fuori del ‘‘regno dell’ignoranza’’, ossia all’interno di spazi che restano estranei ai territori della telecrazia – se non quando qualcuno di voi compare in televisione. In quest’ultimo caso vincere l’ignoranza diventa molto difficile. Come pensate allora di combattere l’ignoranza all’interno del suo regno?
STIEGLER: La risposta che ho dato in precedenza riguardava la televisione, ma disgraziatamente il regno dell’ignoranza ha incominciato a svilupparsi ben prima della televisione, attraverso la proletarizzazione. Ora, il programma di Ars Industrialis è ciò che chiamiamo la “deproletarizzazione”. Pensiamo infatti che oggi la proletarizzazione abbracci tutte le categorie sociali, compresa l’alta borghesia, perché per noi la proletarizzazione non è la pauperizzazione né l’impoverimento. Sovente la proletarizzazione può avere tali conseguenze e purtroppo oggi la pauperizzazione è una conseguenza massiva, ma la proletarizzazione è un’altra cosa. La proletarizzazione è precisamente la perdita del sapere, ossia l’estensione dell’ignoranza, la crescita dell’ignoranza. Essa si produce, secondo noi, innanzitutto per delle ragioni tecnologiche. Ciò significa che la proletarizzazione non è indotta dalla volontà di qualcuno, ma dal fatto che l’industrializzazione e lo sviluppo della tecnologia si producono essenzialmente attraverso l’esteriorizzazione dei saperi nelle macchine, negli strumenti, ecc. Così, lo sviluppo della tecnica comincia sempre con il corto-circuitare i saperi, ossia producendo proletarizzazione. Ed è questo ciò che vuol dire ‘‘proletarizzazione’’ nel senso principale che è stato utilizzato per la prima volta da Marx – ma che è descritto in modo più generale anche da Adam Smith. Noi pensiamo che per combattere questo processo di proletarizzazione non sia assolutamente necessario opporsi alla tecnologia, perché non crediamo che sia possibile opporsi alla tecnologia e all’industria; lo si può combattere, invece, sviluppando un altro rapporto con l’industria e la tecnologia. Da questo punto di vista siamo post-marxisti (lo stesso Marx pensava che fosse necessario impadronirsi dell’industria, e non opporvisi), poiché non utilizziamo la stessa logica dei marxisti, ma al tempo stesso riprendiamo alcune analisi di Marx. Possiamo prendere come esempio il software libero, perché si sviluppa come una nuova pratica della tecnologia che non si basa sulla distruzione dei saperi, ma al contrario è fondato sulla loro condivisione e sul loro sviluppo. Questo aspetto del software libero è stato compreso da molti, a cominciare dai pensatori italiani – Paolo Virno, per esempio, e molti altri che sono vicini a Toni Negri (io mi riferisco maggiormente a Simondon). Insomma, anche noi siamo vicini a chi, in Italia, pensa che il software libero porti in effetti a un nuovo modello economico e industriale in grado di svilupparsi parallelamente. Inoltre, noi pensiamo che tale modello sia generalizzabile, semplicemente poiché è razionale.
Come Ars Industrialis, partiamo dalla tesi per cui il modello consumista, che ha sviluppato la distruzione di tutte le forme di sapere – non solo il saper-fare nella produzione aziendale, ma anche il saper-vivere dei consumatori all’interno della sfera del consumo –, abbia condotto all’assurdità della società in cui ci troviamo. Una società che è diventata estremamente pericolosa, innanzitutto per via dell’inquinamento, per la violenza che libera e per l’instabilità economica – è da tener presente che non solo l’Europa, ma anche gli Stati Uniti e tutto l’Occidente sono quasi in rovina. Dunque, è evidente che bisogna cambiare registro. Ora, quello che dico è un complemento di ciò che ho detto prima su ciò che si può fare nel cambiare il ruolo sociale dei media facendone degli strumenti del sapere. Bene, allo stesso modo è necessario trasformare il ruolo sociale delle macchine nelle aziende, degli strumenti e dei dispositivi nella produzione, per farne degli strumenti di produzione del saper-fare e del sapere industriale.
È necessario aggiungere un altro elemento per combattere questa ignoranza: bisogna teorizzare. Per ricostruire è necessario ricominciare a produrre teoria, e questo è molto importante, perché arriveremo a delle lotte sociali violente – è assolutamente certo. Sta per incominciare, in Grecia si sono avuti dei momenti molto violenti, e se ne avranno sempre di più. È molto pericoloso, perché da questi fenomeni possono restaurarsi forme neofasciste o altro. È quindi molto importante avere delle prospettive. Ma tali prospettive non devono essere delle semplici narrazioni, delle storie di liberazione. È fondamentale invece offrire nuove teorie, che sappiano inventare o utilizzare nuovi modelli economici, o nuovi modelli di ricostruzione dello spazio fisico e dello spazio sociale. Per esempio, è necessario teorizzare le reti sociali, a partire da Facebook. Tutto questo presuppone lo sviluppo di quel che chiamo i ‘‘Digital Studies’’, ossia un nuovo programma di ricerca teorica universitaria, accademica, scientifica, filosofica, artistica, basato sull’attenzione nei confronti di ciò che avviene con la digitalizzazione, poiché tutto quello che sto cercando di descrivere è e sarà reso possibile dalla digitalizzazione.
3) Seguendo il vocabolario di Ars Industrialis, la proletarizzazione è una disindividuazione nella misura in cui è proletarizzato colui che perde il proprio sapere. La proletarizzazione è perciò una privazione del sapere che schiaccia il soggetto sui bisogni, ed in questo senso è una perdita del saper-vivere. Il proletario, o meglio il proletarizzato, non produce i propri modi di esistenza, in quanto essi sono creati dal marketing. Si tratta del problema che lei definisce con il termine ‘‘désapprentissage’’, che potremmo tradurre in italiano con ‘‘disapprendimento’’. Ora, il ‘‘désapprentissage’’ è un concetto ambivalente. Da un lato, infatti, si tratta di un concetto intrinsecamente politico, poiché denuncia gli effetti del capitalismo attuale, dall’altro lato va a decostruire la teoria ‘‘militante’’ del capitalismo cognitivo. Infatti, secondo l’analisi di Ars Industrialis, «i lavoratori intellettuali del capitalismo a dominanza cognitiva, le cui funzioni sono sempre più destinate a parametrare dei sistemi di informazione di cui essi non possono modificarne i principi (poiché sovente li ignorano), subiscono anche una proletarizzazione delle funzioni cognitive superiori, in cui ciò che viene perso è la vita mentale, dello spirito, in quanto istanza critica, ossia razionale» e, aggiungerei, politica. Si presenta perciò un autentico problema della soggettività, e di soggettivazione – per dirla con Foucault – nella misura in cui il regno dell’ignoranza raggiunge il soggetto politico. Potrebbe chiarire questo senso ambivalente del ‘‘désapprentissage’’?
STIEGLER: La questione è molto complicata. Fondamentalmente, come ho detto prima, mi trovo in linea con diversi pensatori italiani, ma anche francesi, che sono vicini a Negri, Virno e altri – come la rivista “Multitude”. Sono in linea con l’idea che il digitale, in particolare attraverso i software open source, renda possibile dei processi di rottura nei confronti della proletarizzazione; al tempo stesso, però, ritengo che le analisi di quel che si chiama il capitalismo cognitivo – e questo è soprattutto evidente, in Francia, nell’economista Moulier Boutang – siano delle analisi naif, perché penso che non dicano in modo sufficientemente chiaro che il capitalismo cognitivo è prima di tutto un processo di proletarizzazione della cognizione. Inoltre, trovo che non separino sufficientemente o chiaramente ciò che nel digitale è realmente produttore di deproletarizzazione, ossia i nuovi processi d’individuazione, e ciò che, al contrario, all’interno del digitale è produttore di nuovi processi di disindividuazione, vale a dire di nuove forme di proletarizzazione. Questa mancanza è dovuta al fatto che essi non vedono – almeno, a mio avviso e per ciò che ho letto – il carattere che io definisco «farmacologico» delle ritenzioni terziarie, ossia delle ritenzioni che permettono il supporto e l’esteriorizzazione del sapere. Questo per me è fondamentale. Il principio che pongo è che i supporti di memoria esteriorizzata sono dei pharmaka – ossia sono precisamente ciò di cui parla Platone nel Fedro, nel senso che quando si esteriorizza qualcosa a livello cognitivo si comincia a privarsi del potere cognitivo stesso, il quale risulta cortocircuitato proprio perché viene esteriorizzato e perciò ci si ritrova proletarizzati. È solo in un secondo tempo, quando ci si serve di tale esteriorizzazione, che si giunge al processo che io chiamo di «re-interiorizzazione», ossia a un secondo stadio che produce una nuova individuazione. Ritengo che i teorici del capitalismo cognitivo – e questo vale anche per André Gorz, che ha molto influenzato questi pensatori – non vedano chiaramente il carattere farmacologico del fenomeno. È per questo che è importante leggere Derrida, ma non soltanto lui, bisognerebbe leggere anche i miei testi, perché Derrida non basta. Rimprovero a Derrida di non aver sviluppato quella che io chiamo una «farmacologia positiva», ossia una farmacologia che permetta di fare una critica dell’economia politica capitalista. Comunque, bisogna leggere la decostruzione e il pharmakon di Derrida: è un aspetto molto importante ed è ciò che manca a Negri e a coloro che lo seguono – ai deleuziani, e sfortunatamente in Francia quando sei deleuziano non leggi Derrida, quando sei derridiano non leggi Deleuze, ed è ridicolo, perché sono dei grandi pensatori. Penso che oggi sia necessario arricchire Derrida con Deleuze e, parimenti, arricchire Deleuze con Derrida. Ma, allo stesso tempo, bisogna emanciparsi da Deleuze e da Derrida, perché sono entrambi del XX secolo, e noi siamo nel XXI secolo. Quindi bisogna pensare con dei concetti nuovi. Non è sufficiente mobilitare Deleuze e Derrida, oggi è necessario produrre dei nuovi concetti. In particolare, io propongo questo concetto della «farmacologia positiva», che non è un concetto di Derrida, ma si appoggia a Derrida, sicuramente.
 4) La sua analisi della società e delle tecnologie contemporanee riprende esplicitamente la situazione che Deleuze ha identificato, negli anni Novanta, con il nome di «società di controllo», in cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione miravano a controllare, a modulare e a plasmare i modi di esistenza individuali e collettivi. Tale prospettiva esprime il pensiero manifestamente politico di Deleuze, quello che denuncia la captazione del consenso e la mercificazione del concetto effettuate dalle nuove tecnologie, ma si può trovare l’origine teoretica di questa prospettiva già in Differenza e ripetizione e in Marcel Proust e i segni. In particolare, Deleuze ha mostrato che apprendere concerne essenzialmente i segni e che i segni non possono essere l’oggetto di un sapere astratto, privato o interiore. Inoltre, l’apprendimento di cui ci parla Deleuze è innanzitutto una sensibilità e un assoggettamento alle forze dei segni. Ora, il controllo effettuato dal marketing e dalle nuove tecnologie, che nella sua analisi provoca il disapprendimento, sarebbe, di fatto, una sorta di sterilizzazione di questa sensibilità. Deleuze sosteneva che la violenza del segno sia ciò che smuove a pensare. Si tratta perciò di una violenza creatrice, che non è quella del controllo, ma che ha ugualmente la funzione di captare l’attenzione del pensatore. Qual è allora il ruolo della violenza nella sua nozione di «disapprendimento»?
4) La sua analisi della società e delle tecnologie contemporanee riprende esplicitamente la situazione che Deleuze ha identificato, negli anni Novanta, con il nome di «società di controllo», in cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione miravano a controllare, a modulare e a plasmare i modi di esistenza individuali e collettivi. Tale prospettiva esprime il pensiero manifestamente politico di Deleuze, quello che denuncia la captazione del consenso e la mercificazione del concetto effettuate dalle nuove tecnologie, ma si può trovare l’origine teoretica di questa prospettiva già in Differenza e ripetizione e in Marcel Proust e i segni. In particolare, Deleuze ha mostrato che apprendere concerne essenzialmente i segni e che i segni non possono essere l’oggetto di un sapere astratto, privato o interiore. Inoltre, l’apprendimento di cui ci parla Deleuze è innanzitutto una sensibilità e un assoggettamento alle forze dei segni. Ora, il controllo effettuato dal marketing e dalle nuove tecnologie, che nella sua analisi provoca il disapprendimento, sarebbe, di fatto, una sorta di sterilizzazione di questa sensibilità. Deleuze sosteneva che la violenza del segno sia ciò che smuove a pensare. Si tratta perciò di una violenza creatrice, che non è quella del controllo, ma che ha ugualmente la funzione di captare l’attenzione del pensatore. Qual è allora il ruolo della violenza nella sua nozione di «disapprendimento»?
STIEGLER: È una questione veramente molto interessante. Comunque, prima di rispondere, direi qualcosa su Deleuze, a proposito delle “tecnologie del controllo” e delle “società di controllo”. Deleuze ha parlato dell’importanza di quella che lui stesso ha definito un’arte del controllo, ossia una produzione artistica nell’epoca delle tecnologie del controllo, che sono anch’esse, a loro modo, un arte del controllo. Prima di parlare della violenza, in senso stretto, vorrei commentare innanzitutto la questione dei segni in Différence et répétition e in Marcel Proust et les signes e in merito a ciò che lei voleva dire. In effetti, sono molto deleuziano a riguardo. Lo sono certamente più di quanto non sia derridiano. Su tale questione sono più vicino a Deleuze che a Derrida, almeno da un certo punto di vista, perché quel che dice Deleuze, in ciò che lei ha sintetizzato, è che bisogna individuare, nel senso di Simondon (ossia non soggettivare, nel senso di Foucault: per me individuare è più rigoroso, come d’altronde Simondon, per me, è più rigoroso di Foucault), bisogna individuare il pharmakon, ossia il processo che è all’origine della dis-individuazione. E i segni sono dei pharmaka. Il segno, per me, è già tecnica. Allora, il problema che ho con Deleuze su tale questione è che riscontro una difficoltà nel conciliare Deleuze con il mio punto di vista sulla tecnica e sulla scrittura. Da molto tempo ormai ho in progetto di commentare un passaggio di ‘‘Selvaggi, barbari, civilizzati’’, in cui Deleuze parla della scrittura, di Leroi-Gouhran, del processo di esteriorizzazione e di Derrida, e penso che Deleuze si perda qualcosa rispetto a quella che definisco la «grammatizzazione». Ritengo che quel che Deleuze ha teorizzato sulla categoria del codice, la codificazione, la decodificazione, ecc., sia necessario pensarlo con il concetto di grammatizzazione, che non è il concetto di grammatologia di Derrida, è più complicato di quest’ultimo. Deleuze e Guattari non lo fanno perché, a mio avviso, hanno un concetto ancora troppo filosofico, o troppo arcaico, o troppo metafisico della tecnica. In Deleuze c’è una sorta di dictat bergsoniano, secondo me. Infatti Deleuze rimane sempre appoggiato al discorso critico che Bergson conduce sulla questione della geometrizzazione dello spazio, la geometrizzazione del tempo, la considerazione spaziale della durata. Per questo motivo si ritrova in Deleuze una specie di diffidenza fondamentale nei confronti della tecnica, di cui ho parlato in uno dei miei libri, commentando un capitolo del suo libro su Foucault che si intitola ‘‘Il diagramma’’. Là penso che Deleuze si sbagli, e lo fa dando una lettura dell’analisi foucaultiana relativa al ruolo del fucile nella costruzione del concetto della fabbrica industriale, capitalista, a partire dal controllo delle armi e dei soldati. Quando si utilizzano delle armi, si sa che esse possono essere rigirate contro gli ufficiali, e i soldati diventano pericolosi quando hanno un’arma in mano. Deleuze commenta questo passaggio molto interessante di Foucault, ma lo fa dicendo che il concetto non è assolutamente il fucile, è il diagramma del fucile, ossia dicendo che non si tratta di una realtà tecnica, ma di un’altra cosa. E penso che questa sia stata una catastrofe, perché secondo me è il luogo in cui Deleuze smette di pensare. Questo è davvero sorprendente, perché Deleuze e Guattari hanno riflettuto sulla macchina attraverso Mumford… Penso allora che qui sia meglio seguire Derrida, forse mi sbaglio – la mia è una sensazione, non è assolutamente una certezza. Comunque sia, per precisare un po’ la mia risposta, sono molto deleuziano rispetto a quel che lei ha descritto del rapporto di Deleuze con il segno, ma aggiungo che il segno è tecnica, e questo non è strettamente deleuziano. Poi, per rispondere alla sua domanda sulla violenza, direi che avrei voglia di ripassare proprio per Derrida, attraverso il testo che conoscerà sicuramente e che si intitola ‘‘La violenza della lettera’’, nel quale Derrida decostruisce il discorso antropologico di Lévi-Strauss, e in cui dice precisamente che ogni segno è già un supplemento, ossia che è già tecnica, e lì sono molto più derridiano che deleuziano, ma aggiungerei che la violenza del supplemento – io la definirei la violenza del pharmakon – proviene da quel che dicevamo prima. Quando una nuova tecnica appare (e per me una nuova parola è una tecnica nuova, non concepisco assolutamente un’opposizione tra linguaggio e tecnica, per me il linguaggio e la tecnica sono la stessa cosa), comincia sempre con il creare una distruzione dei circuiti di «transindividuazione». Questi circuiti di transindividuazione, quando sono pertinenti, quando sono efficaci e necessari, costituiscono dei circuiti infiniti, poiché sono dei circuiti del desiderio, ossia dei circuiti di investimento. E il desiderio non esiste che nell’infinito. Ora, questo è deleuziano, è molto vicino a quel che dice Deleuze: il desiderio esiste nell’infinito. Per esempio, il desiderio geometrico della filosofia – quando Platone scrive «nessuno entri che non sia geometra» è il desiderio della filosofia per la geometria, come in Spinoza – è un desiderio infinito. Si tratta di un desiderio che pone il fatto che un concetto sia ciò che pensa l’infinito. E questo infinito è l’oggetto del desiderio: può essere il desiderio sessuale, può essere il desiderio sublimato del geometra, può essere il desiderio dell’investimento di un eroe in guerra, o quello che volete, ma si tratta sempre di desiderio. Questo desiderio si costruisce attraverso dei circuiti di transindividuazione. Chiamo circuito di transindividuazione una struttura sociale, una struttura del desiderio, una struttura familiare, una struttura artistica, ossia qualunque cosa che trasmette il sapere di generazione in generazione e che permette di costituire dei processi di individuazione collettiva mettendo all’opera delle realtà tecniche, appropriandosene e adottandole. Quando compare una nuova tecnica, essa invade e fa saltare tutti questi circuiti sociali, che sono circuiti del desiderio, e produce delle pulsioni. Questo significa che tutto a un tratto le persone diventano pulsionali, incominciano a comportarsi come delle bestie, perché hanno bisogno di sopravvivere. Oggi noi stiamo vivendo una situazione analoga, a livello planetario, e di una violenza estrema. Inoltre, queste tecnologie ci rendono estremamente veloci, mentre il processo di sviluppo della tecnica è relativamente lento. Ma comunque questa violenza c’è sempre stata; per esempio, Socrate ha bevuto la cicuta perché si è percepito, egli stesso, come violento, e ha sentito che la città era stata violenta con lui. La violenza è sempre esistita, il prezzo dell’individuazione è la violenza. Il problema è che questa violenza dovrebbe essere sublimata per diventare un potere di socialità, ossia una forza sociale, che è poi la forza della Legge, compresa la Legge armata dalle braccia della polizia – quando parlo di violenza della Legge mi riferisco a Walter Benjamin. Il problema è che oggi noi siamo di fronte a una difficoltà, che consiste nel fatto di non riuscire più a trasformare questa violenza in ciò che definisco il secondo momento dell’epoché. Quando infatti appare una nuova tecnologia, essa produce un’epoché, una sospensione nel senso della fenomenologia, un’interruzione, ed essa provoca, attraverso l’interruzione dei circuiti lunghi della transindividuazione, un gran numero di situazioni violente. Ma in seguito si raggiunge un secondo momento in cui questa violenza ci spinge a pensare, ed ecco che ritorno a quello che lei diceva di Deleuze. Questa violenza è ciò che fa pensare e produce l’invenzione di nuovi processi di individuazione. E, attraverso questo secondo momento, la violenza diventa l’origine di una nuova forma di pace: si tratta della pace del polemos, di Eraclito, ossia della pace che regola la città greca. Non è una pace senza alcuna violenza, piuttosto è una violenza che si è trasformata in controversia logica, in violenza intellettuale, ossia in invenzione, in individuazione, in trasgressione pacifica.
5) Sono passati cinque anni dalla pubblicazione di Réenchanter le monde e La Télécratie. In questi libri lei nutriva una certa fiducia per le reti digitali e il Web 2.0, in quanto milieux associati – ossia ambienti tecnici e sociali che permetterebbero la partecipazione alla vita pubblica, sociale e culturale. Durante questi anni la popolazione mondiale ha più volte mostrato una capacità sorprendente – una capacità politica per eccellenza – di utilizzare i social network attraverso delle modalità realmente partecipative. Come commenterebbe, in quanto ‘‘filosofo della tecnologia’’, le rivoluzioni attuali nel Mediterraneo, che utilizzano in modo sistematico le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione?

Marcel Mauss
STIEGLER: Ars Industrialis ritiene che sia assolutamente necessario impadronirsi di queste tecnologie, e non opporvisi, sebbene impadronirsene significhi opporsi al modo in cui esse sono utilizzate dal marketing. Dico questo perché, purtroppo, mentre il marketing riflette molto gli sviluppi di tali tecnologie, la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda il mondo politico, quello accademico o quello artistico. Penso che quel che è avvenuto in Tunisia, in Egitto e ora in molti altri paesi mostri in modo evidente che il Web costituisce il nuovo spazio pubblico di transindividuazione e che quindi si sta instaurando sul Web un processo di individuazione psichica e collettiva. Ora, affinché questo processo si sviluppi e non conduca a gravissimi problemi, come è il caso appunto, della Tunisia e dell’Egitto – poiché in questi paesi la situazione è molto complicata – è necessario elaborare una politica e un’economia del Web. Non bisogna perciò fermarsi a una specie di spontaneismo che si riscontra in molti attivisti – o, come vengono chiamati oggi, hacker-attivisti – che consiste nel credere che la proliferazione spontanea delle reti sociali associate produca un’intelligenza collettiva necessariamente efficace. Io non lo credo nella maniera più assoluta. Ritorno allora a quel che dicevo all’inizio dell’intervista: bisogna ri-articolare in modo strategico i circuiti lunghi della transindividuazione che ereditiamo dalla scienza, dalla filosofia, dall’arte, ecc. con tutti quei nuovi circuiti di transindividuazione che si stanno producendo su queste reti. Bisogna anche condurre delle lotte, e delle lotte molto ben organizzate. Per esempio, bisogna lottare contro Facebook, perché credo che Facebook sia sì qualcosa di molto utile, ma anche di molto invisibile e che sia diventato qualcosa di tossico. Il solo modo di lottare contro Facebook è quello di sviluppare su Facebook, utilizzandolo, un’intelligenza migliore di quella di chi lo dirige – e questo è sicuramente possibile. Ma tutto ciò suppone il costruire delle teorie, suppone la costruzione di concetti, non basta cioè fare dei forum di discussione, o creare delle comunità on line, bisogna lavorare molto. Dunque, questo mi riconduce a ciò che dicevo prima. Oggi è necessario che il mondo produca teorie, e non solo il mondo accademico o scientifico – perché chiunque può produrre teorie: nei partiti politici, nei sindacati, nelle fabbriche, nella miseria, ecc. Ma, d’altra parte, ci sono delle tradizioni di teorizzazione e delle armi della teoria – le nuove armi di cui ci ha parlato Deleuze e che dobbiamo forgiare – ma che non devono essere le armi del passato. Bisogna rinnovare la storia, e questo perché nelle tecnologie, come i computer o i social network, si tratta di metafisica trasformata in industria, e quindi bisogna conoscere Leibniz, bisogna conoscere Spinoza, Aristotele, Platone, ecc. per poter lottare efficacemente contro gli aspetti negativi o pericolosi del digitale. E questa dinamica ha bisogno di quella che io chiamo una ricerca contributiva. A breve uscirà un mio libro, che si intitola Bêtise et savoir au XXI siècle e che ha per sottotitolo Pharmacologie de l’université, in cui propongo di costituire una «internazione» – non un’internazionale. L’internazionale, che ancora esiste, è la Quarta Internazionale Socialista: Bettino Craxi ne faceva parte, così come Mubarak, molti dittatori africani e anche il Partito Socialista francese… mi chiedo quando aderirà anche Berlusconi. L’internazione invece dovrebbe essere costituita da qualcosa che è in un certo senso più che la somma delle nazioni, qualcosa che non è il WTO, che non è il Commercio Internazionale, ma l’unità internazionale di chi pensa, e che viene incontro ai proletari che sono in via di de-proletarizzazione. Questo concetto dell’internazione proviene dall’antropologo Marcel Mauss – il quale, d’altronde, è stato membro della Seconda Internazionale Socialista – e che manifestava l’esigenza di pensare a un’alternativa rispetto all’Internazionale, cioè appunto a quella che ha chiamato l’internazione, da intendersi come un processo di individuazione planetaria. Credo che questa internazione debba costituirsi attraverso le università, a patto che le stesse università vengano ripensate sul modello dell’Università di Bologna del XII secolo, totalmente libera da ogni vincolo nei confronti del Vaticano o dell’autorità imperiale. Oggi è necessario che le università di tutto il mondo si associno – in questo libro propongo appunto un’associazione internazionale delle università – e che rifiutino di sviluppare determinate ricerche che non siano assolutamente sicure, che non siano sfruttate in modo nocivo e che non conducano a danni simili a quelli di Fukushima. È anche necessario, allo stesso tempo, che queste università impongano dei nuovi programmi di ricerca dicendo ‘‘noi siamo pronti a lavorare con voi (voi, cioè gli industriali) su tale progetto, a condizione che voi lo finanziate, e se non lo farete noi sciopereremo’’, e quando tutte le università rifiuteranno di lavorare su quel particolare dominio perché pericoloso o non adeguatamente finanziato, l’industria sarà obbligata a diventare più razionale. Preciso che per me la razionalità non è assolutamente qualcosa del passato, qualcosa di superato o di metafisico. Semmai, è necessario re-inventare la ragione, considerando che la ragione non è più quella dell’Aufklärung, non è più la ragione di Descartes, di Platone, ma è la ragione del Desiderio, è la ragione di Freud, ossia la ragione dopo la scoperta dell’inconscio. Credo perciò che oggi sia possibile ricostruire un progetto universitario che si impadronisca del social networking e che sviluppi ricerche di natura contributiva – lavorando, per esempio, con le persone in Tunisia, in Egitto e altrove – e che questo nuovo progetto sia davvero universale e, al tempo stesso, razionale, attraverso l’internazione delle università. Questo sarà l’argomento principale della mia prossima opera, quindi sarò in grado di sviluppare maggiori dettagli nel libro.
6) Allora, possiamo dire che l’internazione che lei propone sia una sorta di rivoluzione accademica, universitaria e, date le implicazioni, anche politica in un certo senso…
STIEGLER: Sì, è innanzitutto una rivoluzione concettuale. C’è davvero un enorme lavoro da fare, perché, per esempio, abbiamo parlato di alcuni libri di Deleuze e di Derrida, i quali non hanno mai discusso assieme, e questo è deplorevole, anche se direi che lo si può comprendere perché all’epoca era naturale. Ma è deplorevole che oggi ci siano i piccoli deleuziani che fanno la guerra ai piccoli derridiani, e ognuno difenda il suo pezzettino di formaggio per ottenere un posto all’università – e la stessa cosa vale per i seguaci di Hegel, di Nietzsche, di Spinoza, ecc. – questo è inutile e, appunto, deplorevole. Quindi, anche per questo, è necessario fare una rivoluzione culturale all’interno dell’accademia, bisogna smettere di fare filosofia per trovare un posto all’università. Bisogna fare filosofia per salvare il mondo, molto semplicemente. Bisogna fare dell’arte per salvare il mondo, e la stessa cosa vale per la geografia o quant’altro, perché è questa oggi la posta in gioco per tutte le discipline. Si tratta perciò di una rivoluzione culturale che deve prendere piede tra gli stessi universitari, in modo che si possa arrivare a lavorare insieme, in modo transdisciplinare, utilizzando proprio le tecnologie contemporanee, che permettono il lavoro transdisciplinare. E questa strategia suppone che in seguito ci si possa e ci si debba rivolgere al mondo economico e a quello politico per organizzare una rivoluzione che sia politica ed economica, in grado di re-inventare una nuova economia industriale. Questo è molto importante, perché non esistono altre reali alternative, e la responsabilità è innanzitutto degli universitari: invece di dire
è tutta colpa degli economisti, dei politici o dei padroni delle aziende che ci impediscono di lavorare’,
bisogna fare delle nuove proposte economiche, tecnologiche e industriali. Bisogna diventare una forza diffusa, bisogna lavorare con i costituzionalisti per imporre, ad esempio, al WTO di abbandonare il cosiddetto diritto internazionale, in quanto non è un autentico diritto internazionale, non è nemmeno un diritto nel senso della Legge così come i filosofi l’intendono dalla Grecia e da Montesquieu. Il sedicente diritto internazionale è semplicemente un diritto nel senso del contratto, e ciò significa che si tratta di sistemi di negoziazione commerciale: oggi non esiste più un diritto a livello planetario, non ci sono altro che sistemi commerciali. Questo è estremamente grave, perciò è necessario che tale comunità universitaria dell’internazione costituisca le basi di un nuovo diritto planetario, che non si sostituisca ai diritti nazionali – perché non credo assolutamente che la nazione o che le regioni siano finite, stanno invece per rinascere. Il problema è appunto che non esiste diritto planetario e che non c’è riflessione a livello planetario e questo è molto grave.
Il Rasoio di Hanlon
Il rasoio di Hanlon (in inglese Hanlon’s Razor) è un principio metodologico, formulato sul modello del ben più famoso rasoio di Occam, che suggerisce:
| (EN) « Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity » |
(IT) « Non attribuire a malafede quel che si può ragionevolmente spiegare con la stupidità » |
| (Robert J. Hanlon) | |
Il concetto è attribuito allo statunitense Robert J. Hanlon, il quale avrebbe formulato tale assunto, o quantomeno lo avrebbe reso noto, intorno al 1980. In una forma semplificata è anche noto come
| (EN) « Never assume malice when stupidity will suffice » |
(IT) « Non presumere mai cattiveria laddove basti la stupidità » |
| (Robert J. Hanlon) | |
Presunte origini della massima
Tale massima, come detto assertrice di un principio di economia di pensiero sulla falsariga del noto rasoio di Occam (il quale suggerisce di non presumere cause inutili o improbabili per spiegare qualsivoglia fattispecie, laddove esistano cause più probabili e verificabili), è stata per lungo tempo di incerta attribuzione; nel 2001, un certo Joe Bigler di Scranton (Pennsylvania), attribuì la frase al suo defunto amico Robert J. Hanlon, raccontandone anche l’origine: nel 1980 la casa editrice Price Stern Loan di Los Angeles aveva in progetto di dare un seguito al Libro di Murphy, raccolta, a cura di Arthur Bloch, di massime, paradossi e aforismi (detti Leggi di Murphy ) consolidati nella cultura occidentale; per tale secondo libro, che fu dato alle stampe con il titolo di Murphy’s Law Book Two: More Reasons Why Things Go Wrong [2], l’editore indisse un concorso a premi al fine di stimolare i lettori a suggerire le migliori massime. Tale Robert J. Hanlon, secondo Bigler, inviò all’editore la battuta in oggetto e fu premiato con 10 copie del nuovo libro, una delle quali fu donata da Hanlon allo stesso Bigler.
Un’altra versione, che pare contraddire quella suesposta, viene dal blogger canadese Bill Clarke, il quale sostiene che la frase è originariamente sua […].
Il principio di presumere ignoranza o stupidità laddove si tenderebbe istintivamente ad assumere malafede o cattiveria, tra l’altro, viene indicato come indice di saggezza: difficilmente si considera se stessi in malafede, onde, assumendo malafede come causa di una controversia, si tende ad attribuirla alla controparte. Presumendo invece incompetenza, o ignoranza, si è più portati a considerare che la responsabilità delle incomprensioni può essere ascritta alla propria parte e non necessariamente a quella altrui[7].
Citazioni analoghe
 A prescindere dalle varie attribuzioni, il concetto, che nelle linee essenziali suggerisce di non presumere cattive intenzioni in quei casi dove l’errore umano o la semplice mancanza di raziocinio basterebbero a giustificare un’azione sconveniente, fu espresso in varie forme in epoche anteriori a quelle dei soggetti citati in precedenza: Wolfgang Goethe, nei Dolori del giovane Werther (1774), scrive infatti che
A prescindere dalle varie attribuzioni, il concetto, che nelle linee essenziali suggerisce di non presumere cattive intenzioni in quei casi dove l’errore umano o la semplice mancanza di raziocinio basterebbero a giustificare un’azione sconveniente, fu espresso in varie forme in epoche anteriori a quelle dei soggetti citati in precedenza: Wolfgang Goethe, nei Dolori del giovane Werther (1774), scrive infatti che
…l’incomprensione reciproca e l’indolenza fanno forse più male nel mondo della malignità e della cattiveria. Almeno queste due ultime sono certo più rare;
Friedrich Schiller, altresì, disse che
…contro la stupidità anche gli dèi possono nulla.
 Ad Albert Einstein è attribuita una frase (apocrifa) sul potere della stupidità:
Ad Albert Einstein è attribuita una frase (apocrifa) sul potere della stupidità:
Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma quanto al primo ho ancora dei dubbi.
Nel manuale universalmente noto come Truppenführung, saggio sulle strategie militari e sulle tecniche di comando a opera di un generale tedesco, Kurt von Hammerstein-Equord, l’alto ufficiale traccia quattro profili-base di soldato, in base ai vari gradi di indole e di intelligenza[9]: Hammerstein pone ai gradi più alti gli intelligenti e i laboriosi, adatti secondo lui alle cariche di Stato Maggiore; quanto a quelli stupidi e pigri, li considera in qualche maniera utili; coloro che uniscano intelligenza e pigrizia possono essere in qualche maniera adatti al comando, in quanto dotati di «temperamento e nervi saldi per affrontare qualsiasi situazione»; coloro da allontanare subito sono, invece, gli stupidi laboriosi (si potrebbe presumere che la ragione di questo convincimento sia nel fatto che, essendo laboriosi, essi non si limitino a essere inutili come quelli pigri, ma dannosi).
Carlo Maria Cipolla formulò una teoria della stupidità umana nel suo libro Allegro ma non troppo (1988). Secondo la terza legge della stupidità:
Una persona è stupida se causa un danno a un’altra persona o a un gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno.
Secondo la quinta legge della stupidità:
La persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista» C. M. Cipolla, cit.
La “teoria del casino”
Alternativa a quella della stupidità contro la malvagità, vi è una massima di Sir Bernard Ingham, per molti anni portavoce del Primo Ministro britannico Margaret Thatcher, che contrappone caos a macchinazione (prima il casino e poi il complotto [11]). Essa infatti recita:
Molti giornalisti hanno finito per sposare teorie di complotti governativi laddove, vi assicuro, sarebbe stato più produttivo per loro attenersi alla teoria del casino.
La banalità del male
La filosofa tedesca Hannah Arendt nel 1963 ha usato un’argomentazione simile per spiegare il pensiero (o, paradossalmente, l’assenza di esso) di Adolf Eichmann, gerarca nazista processato nel dicembre 1961 in Israele. Le riflessioni elaborate da Arendt sono contenute nel saggio La banalità del male.
Bibliografia
Arthur Bloch, Il secondo libro di Murphy. Nuovi motivi per cui le cose vanno storte, Milano, Longanesi [1980], 1989. ISBN 88-304-0862-X
Wolfgang Goethe, Franco Fortini (a cura di), I dolori del giovane Werther, Milano, Garzanti [1991], 2008. ISBN 88-11-36006-4
Robert Heinlein, Stefano Magagnoli (a cura di) (marzo 1999). Logica dell’Impero. Urania Classici (264): 238 (2). ISSN: 1120-4966. URL consultato in data 10-6-2009.
Bruce Condell, David T. Zabecki (a cura di), On the German Art of War: Truppenführung. German Army Manual for Unit Command in World War II, Mechanicsburg, PA, Stackpole Books [2001], 2009. ISBN 978-0-8117-3552-0
Carlo Maria Cipolla, Allegro ma non troppo, Bologna, Il Mulino, 1988. ISBN 88-15-01980-4










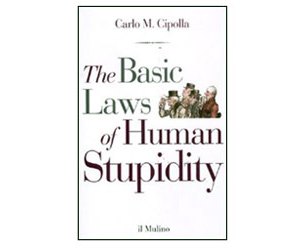










Commenti recenti