Simmel è stato il primo ad intuire che le dimensioni del gruppo influenzano le sue dinamiche. Nel testo seguente la sua analisi delle proprietà della coppia e del trio e la straordinaria analisi filosofica del loro significato.
La diade deriva le sue proprietà da un fatto fondamentale: la sua sopravvivenza in quanto insieme è legata al consenso dei due sottoinsiemi che la compongono. Basta che A o B per qualche motivo escano dall’insieme e la diade non esiste più. Da questo derivano alcune sue proprietà strutturali.
Ad esempio, la diade è costretta alla intimità e alla vicinanza, consente solo i sentimenti che legano (l’amore, l’odio), non tollera l’indifferenza, non conosce la trascendenza, è ossessionata dall’orizzonte della propria fine, e deriva dalla sua mortalità costitutiva la sua tonalità tragica ed estrema («il vero e proprio luogo di una genuina tragedia sociologica»).
L’ingresso di un terzo elemento modifica radicalmente le proprietà della diade. Alla sua ineluttabilità – stare con l’altro, o separarsi da lui – si sostituisce una gamma di possibilità complesse: l’alleanza di A con C contro B, C come capro espiatorio e pharmakos, C come tertius gaudens che massimizza in modo calcolato i propri benefici ‘vendendo’ il proprio sostegno talvolta ad A talvolta a B, C come gate keeper delle comunicazioni indirette tra A e B ormai incapaci di comunicazione diretta (quanti figli nascono per questo), C come ‘giudice’, ecc.


















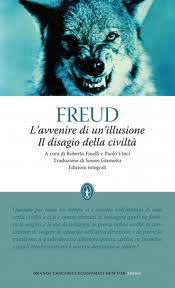
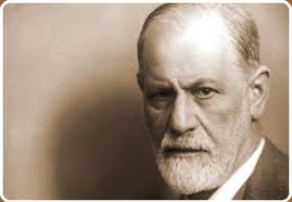


Commenti recenti