In questo articolo cerchiamo di studiare il pensiero educativo platonico, senza affrontare la sua gnoseologia. Questo ci permette di non spezzare il filo della riflessione sull’evoluzione del concetto di areté e di apprezzare i significativi cambiamenti che intervengono nella paideia filosofica.
La lezione fa parte del programma di pedagogia antica, le cui videolezioni sono disponibili qui.
Indice
1. L’educazione è insegnare a pensare (videolezione 8)
1.1 La critica alla scrittura e all’insegnamento trasmissivo [Fedro]
1.2 Educare l’anima a riconoscere la verità [Menone e Simposio]
2. L’areté è senza padrone (videolezione 9)
2.1 La natura umana nel mito della biga alata [Fedro]
2.2 La libertà nel mito di Er [La Repubblica, X]
3. L’educazione nella città giusta (videolezione 10)
3.1 Schiavitù e liberazione: l’allegoria della caverna [La Repubblica, VII]
3.2 Politica ed educazione: libertà ed eguaglianza nella kallipolis
Il pensiero educativo di Platone si sviluppa in continuità con quello di Socrate di cui porta a termine la battaglia anti-sofista.
I suoi temi sono, infatti, come quelli del maestro e degli stessi sofisti, la ricerca di cosa sia la virtù (la perfezione dello spirito) o aretè e il problema di come e se sia possibile insegnarla.
Lo sfondo su cui Platone costruisce le risposte a queste domande non è però uno scenario qualsiasi, ma quello disegnato dal più grande filosofo della tradizione occidentale. Ecco perché, discutendo della virtù, Platone ci mostra via via cosa significa apprendere e cosa insegnare, cosa vuol dire essere intelligenti, essere liberi ed essere giusti.











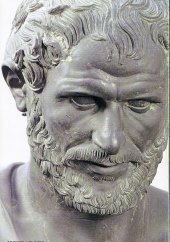
Commenti recenti